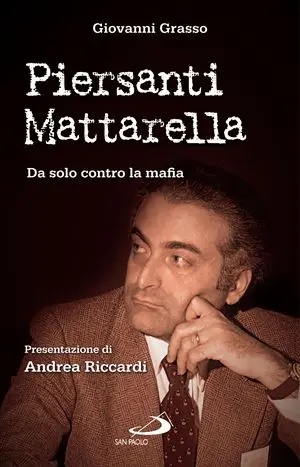PHOTO
È la mattina del 6 gennaio 1980, domenica. Scrosci di pioggia fredda intervallati da fastidiose raffiche di vento battono la città di Palermo. A casa Mattarella, al secondo piano di via della Libertà 147, il papà, Piersanti, presidente della Regione Sicilia, ha appena chiuso una lunga conversazione telefonica con Corrado Belci, dirigente nazionale della Dc. Guarda l’orologio. Manca una manciata di minuti all’inizio della messa delle 12.30. Sollecita amorevolmente la moglie e i due figli, Maria e Bernardo: «Forza, è ora di andare. Non facciamo tardi oggi che è l’Epifania».
La moglie del presidente, la signora Irma Chiazzese, non si sente un granché. Un leggero malore che ha finito per rallentare tutta la famiglia. Il piccolo gruppo termina in fretta i preparativi e finalmente si mette in moto. In genere i Mattarella frequentano la parrocchia di Santa Lucia, a un passo dall’Ucciardone, ma sono invitati a pranzo da amici che abitano in un’altra zona. E così il programma è cambiato. La meta è la chiesa di Francesco di Paola, a circa due chilometri da casa.
Quella domenica il presidente, dimissionario dopo una crisi di governo regionale, è senza scorta. Il delicato incarico che ricopre in Sicilia lo espone a pressioni e minacce di ogni tipo e l’anno che si è appena chiuso ha fatto contare, nella sola Palermo, più di cinquanta omicidi di mafia. In questa lista sterminata di morti ammazzati non ci sono solo picciotti appartenenti a bande rivali. Cosa Nostra ha puntato le armi in alto: contro il giornalista Mario Francese, indagatore coraggioso dei misteri mafiosi, contro il giudice Cesare Terranova, ex deputato della Sinistra Indipendente, ucciso insieme al maresciallo di polizia Lenin Mancuso, contro il capo della squadra mobile Boris Giuliano, energico ed efficace investigatore. Ma tra i morti eccellenti di Palermo del 1979 c’è anche il segretario provinciale della Dc, Michele Reina, andreottiano e sostenitore dell’apertura a sinistra. Il primo politico di rilievo assassinato dalla mafia.
Una mafia che in quello stesso anno lascia sanguinose impronte anche lontano dalla Sicilia, in un oscuro intreccio con poteri occulti, servizi deviati, bande criminali e uomini d’affari. Basta pensare all’omicidio di Giorgio Ambrosoli, l’integerrimo liquidatore della Banca Privata Italiana, un istituto bancario sotto il controllo di Michele Sindona, personaggio a cavallo tra Cosa Nostra e ambienti italiani e stranieri della politica, della finanza e della massoneria. O all’uccisione di Mino Pecorelli, il discusso giornalista depositario di torbidi segreti sulle trame dei potenti italiani. Inoltre, in tutto il Paese gli uomini delle istituzioni sono a rischio, potenziali obbiettivi del terrorismo politico, rosso o nero, che ha già sperimentato sul campo tutta la sua micidiale capacità operativa.
Mattarella queste cose le sa. Ha vissuto sulla sua pelle, con trepidazione e dolore, il rapimento e l’assassinio del suo maestro e amico, Aldo Moro. Ha partecipato ai funerali di Boris Giuliano e del giudice Terranova, due servitori dello Stato che la mafia la conoscevano e la combattevano sul serio; è toccato a lui commemorare, in piazza e all’Assemblea Siciliana, il collega di partito Michele Reina. Ma, nonostante tutto, nei giorni di festa ha l’abitudine di congedare gli agenti assegnatigli per la protezione. «Hanno diritto anche loro», spiega, «di passare le festività con la famiglia». Anche se agli amici più intimi ha confidato: «Se vogliono ammazzarmi, lo fanno egualmente»
Il killer e i complici, che hanno seguito per settimane i suoi spostamenti, annotando abitudini, orari e percorsi, sanno che quella domenica Mattarella sarà senza scorta. Sanno anche che per loro sarà maledettamente più facile ammazzare un uomo pubblico, simbolo del rinnovamento politico siciliano, quando si troverà – totalmente indifeso – in un momento del tutto privato, intimo, familiare. La persona che si parerà loro davanti quando sarà ora di premere il grilletto non sarà un politico o un esponente delle istituzioni, ma un marito e un padre affettuoso che, come tanti altri, esce di casa nell’ultimo giorno delle vacanze natalizie per andare a messa insieme alla famiglia. E che cosa importa se Piersanti ha solo quarantaquattro anni, la moglie quarantadue, il figlio Bernardo appena venti e se l’adorata secondogenita Maria ha da pochi giorni festeggiato il diciottesimo compleanno, a casa, con amici e parenti, ballando fiera con il suo papà? Che peso può avere nelle logiche di un’organizzazione criminale il fatto che i Mattarella sono una famiglia unita e felice, con tanta voglia di continuare a esserlo? Non conta nulla – o meno di nulla – se Irma e Piersanti si amano come il primo giorno in cui si sono incontrati, se sognano di invecchiare insieme, se vogliono godersi ancora per lunghi anni la tenerezza reciproca, l’affetto dei figli e i futuri nipotini.
Questi sono pensieri che non possono e non devono sfiorare la mente di un criminale. Il killer deve rimuovere dalla sua coscienza e dal suo cuore ogni traccia, anche minima, di umanità. «Era proprio un robot, che sparava come se sparasse a una pietra o a una sedia», testimoniò la vedova Mattarella in tribunale. Robot, ossia, etimologicamente, macchina che svolge lavori “pesanti” al posto dell’uomo.
La famiglia Mattarella si avvia verso il garage, a pochi metri dal portone di casa. Mancano ormai pochi minuti all’una e il gruppo si divide: Piersanti e il figlio scendono in garage per la piccola rampa. La moglie del presidente, la figlia e la suocera attendono sul marciapiede accanto al cancello, chiacchierando. È lì che gli occhi di Irma incrociano quelli di un giovane poco più che ventenne, un po’ tarchiato, con un giubbotto celeste e il cappuccio calato sulla testa, che le si para davanti con una strana andatura, quasi a balzi, per poi infilarsi nel cortile del bar attiguo. Quel viso un po’ tondo, dalla carnagione chiara e le gote arrossate, le si stampa per sempre nella mente. «Aveva occhi di ghiaccio», ricorderà in più occasioni. Così come le rimarrà impressa una smorfia, un ghigno, non si capisce se di sforzo, di tensione o di giubilo, che appare sul volto del killer appena compiuta la sua missione di morte.
Piersanti si mette alla guida della sua 132 blu. Bernardo non sale. Rimane di sotto per chiudere la porta del box. Prima di scendere ha notato distrattamente, a pochi metri dal cancello, una 127 bianca in sosta sul marciapiede con due uomini a bordo.
Lo spazio di manovra all’interno del garage è piuttosto esiguo. L’automobile percorre la rampa a marcia indietro. Poi si arresta sul passo carrabile per far salire la famiglia. Irma si sistema davanti, accanto al marito. Maria e la nonna dietro. Sono pochi attimi, lo spazio di un paio di respiri prima dell’orrore e della tragedia.
Maria sta parlottando con la nonna. Sente un gran botto, si gira di scatto e vede i cristalli del finestrino anteriore andare in frantumi: «C’era la canna nera di una pistola diretta contro papà, sparava. Lui si è reclinato sulle gambe di mamma… Il killer ha fatto il giro della macchina e ha continuato a sparare dall’altra parte».
Da un’altra prospettiva, dal fondo della rampa, Bernardo scorge un giovane con un giubbotto celeste che si accosta al finestrino del padre, si china leggermente, prova con forza ad aprire lo sportello senza riuscirci. Allora tira fuori un revolver, una micidiale calibro 38, e fa fuoco. Bernardo ricorda una sequenza imprecisata di colpi e un grido soffocato del padre. Paralizzato dall’orrore, riesce a seguire con gli occhi il sicario che si avvicina alla 127 scambiando parole e gesti concitati con il complice. L’uomo in macchina consegna qualcosa nelle mani del killer. Le indagini stabiliranno che la prima pistola si è inceppata e che il giovane con il giubbotto celeste se n’è fatta dare una seconda.
Il sicario fa un rapido dietrofront. Si accosta di nuovo alla macchina del presidente della Regione, stavolta dal lato dove siede Irma. Ha come un attimo di esitazione quando vede la moglie che cerca disperatamente di fare scudo con le mani al marito, ma l’ordine ricevuto è tassativo: Mattarella deve morire. Il killer si sposta, prende la mira dal finestrino posteriore e spara ancora.
Racconta la moglie alla polizia subito dopo l’omicidio: «Non so come sia successo. Ma lui [il killer, nda] se n’è andato. L’ho seguito con gli occhi, mi è sembrato che fosse quasi entrato in macchina. Stringevo Piersanti e guardavo quell’auto sperando che il Signore li facesse andare via. E invece no: il complice, quello alla guida, ha fatto dei gestacci, proprio come se gridasse all’assassino di tornare a sparare. E lui è venuto di nuovo verso di noi. I suoi occhi fissi sui miei, ha sparato l’ultimo colpo».
Irma è rimasta leggermente ferita a una mano, ma quasi non se ne accorge. Carezza il marito riverso su di lei ormai in stato di incoscienza, in una pozza di sangue. Il killer saltella, ancora, in una grottesca danza di morte. Il suo viso si è contratto in una smorfia beffarda mentre, quasi senza fretta, si avvia verso la 127 targata Palermo che lo aspetta con il motore acceso. L’utilitaria sgomma e parte di corsa, dileguandosi in direzione di piazza Politeama. Tutta la scena è stata seguita dall’alto dalla collaboratrice domestica della famiglia Mattarella, la signora Giovanna, che era affacciata alla finestra. Anche lei è rimasta colpita dallo strano modo di camminare dell’assassino.
Racconta oggi Maria con voce tranquilla, ma con lo sguardo velato di tristezza: «Ne abbiamo discusso tante volte con mamma. E abbiamo concluso che è stato un bene che ci fossimo trovati tutti insieme in quel momento, con papà. È come se lo avessimo accompagnato fino alla fine. Non abbiamo mai pensato: “Sarebbe stato meglio non essere lì, non assistere alla scena della sua morte”».
Accorrono i primi passanti, qualcuno esce di corsa dal bar che si trova tra l’abitazione dei Mattarella e il garage. Proprio dal telefono di quel bar Bernardo riesce, in stato di trance, a chiamare il 113. Una seconda telefonata è per lo zio Sergio, il fratello minore di Piersanti, che abita anche lui a via della Libertà, a un paio di isolati dal luogo dell’attentato. Sopraffatto dal dolore e dallo shock, Bernardo non riesce a dirgli tutta la verità: «Zio, corri giù, c’è stato un incidente a papà». Sergio scende subito in strada, preoccupato. La scena che gli si para davanti, con quell’auto crivellata di colpi e piena di sangue, è violenta, allucinante, insostenibile. L’ambulanza tarda ad arrivare, sul luogo è però giunta una volante della polizia. C’è anche un medico, Orietto Giuffré, amico dei Mattarella, che si trovava lì di passaggio. Aiuta i familiari a caricare Piersanti, in agonia, sulla volante. A bordo sale anche Sergio, davanti, mentre il dottor Giuffré si sistema dietro, accanto al presidente. Lo accompagnano per l’ultimo viaggio, a sirene spiegate, verso il pronto soccorso di Villa Sofia. Non è un tragitto lungo ma le speranze di sopravvivenza del presidente si assottigliano. Sergio ricorda ancora l’espressione sempre più sconfortata di Giuffré e la voce concitata proveniente dalla radio della polizia: «C’è stato un attentato a via della Libertà… Non sappiamo se si tratti di un giudice o del presidente della Regione… ». E il poliziotto a bordo che quasi urla: «Confermiamo, è stato colpito il presidente della Regione».
Piersanti non ha mai ripreso conoscenza. Anche se qualche giornale scrive, romanzando, che prima di morire avrebbe sussurrato parole riferite all’adorata moglie: «Non dite nulla a Irma, non fatele sapere». All’arrivo all’ospedale il ferito viene caricato in barella e portato di corsa dal medico di guardia che prova subito a rianimarlo con un massaggio cardiaco. Per il presidente della Regione Sicilia, raggiunto da sei pallottole alla tempia, alle spalle, al petto, al fianco destro, non c’è scampo. Il suo giovane cuore si ferma sette minuti dopo l’ingresso in quell’ospedale. L’autopsia rivelerà che già i primi colpi sono stati fatali. È Sergio, affranto, a comunicare alla folla che si è concentrata fuori dall’ospedale che «non c’è più nulla da fare».
Nella chiesa di San Francesco di Paola la messa dell’Epifania si è appena conclusa: i fedeli, ancora ignari dell’attentato, sciamano festosi verso l’uscita. Il vangelo di Matteo ha appena ricordato la storia dei magi, venuti da Oriente, e la loro «gioia grandissima» nell’assistere alla manifestazione di Dio in quel bambinello nella grotta. Ma per la famiglia Mattarella il Signore quel giorno si è manifestato sotto il simbolo misterioso e dolente del legno della Croce.
In ospedale si allestisce una prima provvisoria camera ardente che diventa subito meta di parenti, amici e autorità cittadine. Ad accogliere tutti c’è il fratello Sergio, con il golf ancora sporco di sangue. Al suo fianco, affranta, sua moglie Marisa, sorella minore di Irma. Arrivano il presidente dell’Assemblea Siciliana il comunista Michelangelo Russo, il segretario della Dc regionale Rosario Nicoletti, particolarmente provato, e quello del Pci Gianni Parisi. Sfilano davanti alla salma deputati regionali di tutti i partiti, leader sindacali, gli amici del “Gruppo politica”, la corrente di giovani professorini fondata da Mattarella. Si affacciano costernati il questore, il prefetto, il comandante provinciale dei carabinieri.
Entrano trafelati anche due agenti della scorta del presidente: sono sconvolti. Il più giovane dei due ha ancora sotto braccio la paletta rossa con cui si è fatto largo tra le auto per raggiungere rapidamente l’ospedale: alla vista del corpo senza vita del suo presidente quasi sviene per l’emozione e viene portato via a braccio dai colleghi.
La gravissima notizia dell’assassinio di Piersanti Mattarella fa subito il giro dell’Italia e del mondo. “L’Ora”, il giornale progressista di Palermo, esce nel pomeriggio in edizione straordinaria, consegnando alla città una sequenza di immagini crude e dolorose. Due fotografi del quotidiano, Letizia Battaglia e Franco Zecchin, si trovavano per caso nei pressi di via della Libertà. Sentiti gli spari, sono accorsi sul luogo dell’attentato. In una foto si scorge la signora Mattarella di spalle, ancora dentro la macchina, che aiuta il cognato Sergio a far uscire dall’abitacolo il corpo del marito.
I sindacati confederali siciliani, Cgil, Cisl e Uil, proclamano immediatamente uno sciopero generale con corteo a Palermo per il giorno successivo, mentre i lavoratori di tutta Italia sono invitati a incrociare le braccia per un quarto d’ora in segno di protesta contro la violenza. L’uccisione del presidente della Regione siciliana è un fatto senza precedenti. Nell’Italia di quegli anni, insanguinata dal terrorismo e dalla mafia, attentati e uccisioni sono quasi quotidiani. E talvolta si corre il rischio di forme di assuefazione alla violenza. Non è questo il caso. Sconcerto, sdegno e commozione si diffondono rapidamente in tutto il Paese. Colpisce la personalità del giovane presidente ucciso, la cui opera di rinnovamento in un contesto difficile come quello siciliano aveva suscitato simpatia. Impressiona la gravità del nuovo attacco portato al cuore dello Stato, a poco meno di due anni dal rapimento e dall’assassinio di Aldo Moro, a cui Mattarella era politicamente e umanamente legato. Turbano le modalità, insolite e crudeli, dell’omicidio.
Da Roma si fa sentire forte la voce del presidente della Repubblica Sandro Pertini, che aveva conosciuto da vicino Piersanti, in novembre, durante una visita di tre giorni in Sicilia. Era stato Mattarella a invitarlo. E dopo quella visita Pertini si era iscritto nella lunga lista dei simpatizzanti del giovane politico siciliano. In un messaggio alla vedova, il presidente scrive di piangere «l’uomo giusto e coraggioso di cui ho conosciuto e apprezzato […] l’ingegno e le grandi qualità umane, civili e politiche». Il capo dello Stato scrive anche al segretario nazionale della Dc, Benigno Zaccagnini, rilevando che l’omicidio Mattarella «è un altro pesante tributo di sangue che la Dc paga alla difesa della Repubblica e dell’ordine democratico contro ogni tipo di criminalità eversiva».
Subito dopo parla il presidente del Consiglio Francesco Cossiga. Si dice convinto che «le forze dello Stato, con la solidarietà e l’appoggio fattivo di tutti i cittadini, non lasceranno impunito l’assassinio di Mattarella, assicurando alla giustizia esecutori e mandanti». Parole che purtroppo saranno smentite – almeno parzialmente – negli anni successivi.
Messaggi di condanna per l’efferato omicidio e di solidarietà alla famiglia arrivano anche dai presidenti di Camera e Senato, Nilde Iotti e Amintore Fanfani. Il segretario della Dc Benigno Zaccagnini si trova a casa, a Ravenna, indisposto. Vorrebbe partire subito per Palermo, ma le condizioni fisiche non glielo permettono. La notizia della morte del giovane amico riapre una ferita dolorosa: Zaccagnini non si è mai ripreso dall’uccisione di Moro. Nel suo messaggio tiene a ricordare che Piersanti «è stato uno dei giovani più vicini e più stimati da Aldo Moro, di cui condivise sempre visione e impegno politico». E ora ha condiviso con l’antico maestro il tragico destino. Per la Dc partono alla volta di Palermo il presidente del consiglio nazionale Flaminio Piccoli e il vicesegretario Nino Gullotti.
Anche Giovanni Paolo II fa arrivare alla famiglia Mattarella, attraverso il cardinale di Palermo, parole di cordoglio e di conforto. Commosso dall’uccisione di quel giovane presidente di Regione anche il presidente della Commissione della Comunità Europea Roy Jenkins, che ha sperimentato proprio a Palermo il vento rinnovatore portato dalla presidenza Mattarella. A via della Libertà, intanto, le forze dell’ordine tengono a bada una piccola folla di curiosi, fotografi e giornalisti ma anche tanti semplici cittadini accorsi a testimoniare vicinanza e dolore. Nelle foto di quel giorno si scorge un giovane, con un cappotto color cammello, che ispeziona l’automobile del presidente Mattarella.
È Piero Grasso, futuro procuratore antimafia e presidente del Senato, all’epoca sostituto procuratore a Palermo. Era lui di turno quel 6 gennaio. E verrà successivamente incaricato delle prime indagini dal procuratore capo Gaetano Costa. Magistrato schivo e irreprensibile, anche Costa sarà ucciso nell’agosto del 1980, in un agguato a Palermo. «Di lui», commentarono i suoi colleghi, «si poteva comprare solo la morte».
Le indagini sulla morte del presidente della Regione vengono avviate in tutte le direzioni e senza risparmiare mezzi. Non si tralascia alcuna pista: quella di mafia, innanzitutto, correlata all’attività di rinnovamento della Regione promossa da Mattarella. Un’attività che sicuramente ha pestato i piedi a qualcuno interessato a mantenere una situazione di opacità, di favoritismi e di inefficienza. Ma a nessuno sfugge nemmeno la inquietante analogia che lega il delitto Mattarella a quello Moro, avvenuto poco meno di due anni prima. Entrambi lavoravano per favorire l’evoluzione in senso compiutamente democratico del Pci attraverso il dialogo, il confronto e l’associazione all’area di governo. Mattarella, addirittura, aveva preceduto il suo maestro nella formazione della sua prima giunta regionale, avvenuta con il voto favorevole dei comunisti siciliani. Una formula, definita di “solidarietà autonomistica”, che anticipava fattivamente la solidarietà nazionale di Moro e Berlinguer. Ma il progetto politico di Moro e di Mattarella aveva molti nemici non solo nella Dc siciliana e nazionale. Erano infatti in molti, in Italia e perfino all’estero, a giudicarlo velleitario e pericoloso.
Polizia e carabinieri organizzano interrogatori, setacciano interi quartieri, effettuano perquisizioni e posti di blocco in tutta l’isola. Vengono ascoltati testimoni, fermati e interrogati militanti di estrema destra ed estrema sinistra. Vertici convulsi si svolgono tra procura, questura e prefettura. Alla polizia arriva una telefonata anonima. Un uomo racconta di aver visto due persone uscire dalla 127 bianca in via De Cristoforis, a meno di un chilometro e mezzo dal luogo della sparatoria. L’auto, al vaglio degli inquirenti, ha una targa falsa, costruita con la giustapposizione di pezzi di due targhe trafugate; risulta rubata a Palermo, in via de’ Cosmi, la sera prima del delitto: il proprietario l’aveva lasciata un attimo in sosta in seconda fila con le chiavi attaccate al quadro. Secondo l’anonimo, i due giovani sarebbero entrati in un androne di un palazzo per cambiarsi d’abito. Successivamente sarebbero saliti su una Fiat 850 grigia, guidata da un terzo complice. Il testimone fornisce perfino la targa. Sembra un’ottima pista ma, rintracciato e interrogato l’ignaro proprietario della 850, i poliziotti si rendono conto che si tratta di un clamoroso falso.
Gli inquirenti ascoltano subito la vedova Mattarella – appena tornata dal centro traumatologico dell’Inail, dove le hanno medicato la mano ferita – i figli e la collaboratrice domestica. Le loro testimonianze permettono alla polizia di diffondere un identikit del killer, ritratto con e senza occhiali.
Arrivano anche le prime rivendicazioni telefoniche. Sono però tutte successive alla diffusione in tv della notizia della morte del presidente e, per questo, devono essere vagliate con grande attenzione. La prima è alle 14.55. Un giovane telefona alla sede palermitana dell’Ansa. Ha una voce insicura, dice di parlare a nome dei Nuclei Fascisti Rivoluzionari. Scandisce: «Rivendichiamo l’uccisione dell’onorevole Mattarella in onore dei caduti di Acca Larenzia a Roma».
I caduti di Acca Larenzia – madre adottiva di Romolo e Remo – dicono poco o nulla ai giornalisti palermitani. Fanno subito ricerche e alla fine collegano quel nome mitologico a un grave e recente fatto di sangue avvenuto nella capitale giusto due anni prima. Il 7 gennaio del 1978, infatti, due ragazzi del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, erano stati uccisi da estremisti di sinistra in un agguato davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano in via Acca Larenzia, nel quartiere Tuscolano. Un terzo giovanissimo militante missino, Stefano Recchioni, era morto poche ore dopo, colpito da un proiettile sparato da un ufficiale dei carabinieri durante violenti tafferugli scoppiati di fronte al luogo della tragedia. Quella strage che aveva coinvolto, sia pure in momenti diversi, militanti di estrema sinistra e forze dell’ordine, segnò per esplicita ammissione dei protagonisti un momento di non ritorno nella recrudescenza dell’azione dei Nuclei Armati Rivoluzionari (Nar), la più micidiale organizzazione terrorista di estrema destra.
Alcune ore più tardi, poco prima delle 19, un uomo telefona alla sede di Messina della “Gazzetta del Sud” per una seconda e opposta rivendicazione. L’uomo dice di parlare a nome delle Brigate Rosse e annuncia il rilascio imminente di un comunicato, che però non verrà mai diramato. Alla redazione romana del “Corriere della Sera” arriva successivamente un’altra telefonata che attribuisce l’uccisione alla colonna palermitana dell’organizzazione terrorista di sinistra “Prima Linea”. Il giorno dopo a “L’Ora” di Palermo, quarta rivendicazione, ancora a firma Br. La macchina del depistaggio è in pieno movimento e gli inquirenti mostrano di non credere troppo a quelle dichiarazioni.
In serata il corpo di Piersanti viene trasportato in via della Libertà. L’ha deciso Irma. Vuole avere ancora il marito accanto, a casa, per l’ultima notte. La salma viene sistemata nello studio del presidente, in mezzo ai libri e alle carte. Le visite di cordoglio non conoscono interruzioni. I presenti ricordano un abbraccio tra la vedova Mattarella e il segretario regionale della Dc Rosario Nicoletti, amico e sostenitore di Piersanti. Erano andati tutti a cena con le mogli, pochi giorni prima, al Charleston: lui, Piersanti, Sergio e un’altra coppia di amici. Avevano parlato anche di politica, del partito e della Sicilia da rinnovare. Nicoletti, impietrito dal dolore, confida a Irma: «Hanno buttato una moneta. O usciva lui o uscivo io». Lei replica premurosamente: «Lei ha figli piccoli, si guardi le spalle, si guardi le spalle…».
Quattro anni dopo, il 17 novembre del 1984, Rosario Nicoletti si suicidò gettandosi dalla finestra della sua abitazione al quarto piano di via Lincoln. Un gesto improvviso e inaspettato le cui reali motivazioni non sono state mai chiarite completamente.
Su un altare improvvisato accanto alla bara del presidente della Regione, monsignor Nino Porcaro, parroco di Santa Lucia e amico di Piersanti, celebra a casa la messa domenicale per la famiglia Mattarella. Come noterà il cardinale Pappalardo nell’omelia funebre, la messa festiva cui Mattarella doveva assistere «fu tramutata in una messa di suffragio ».
Per una sorprendente coincidenza il “Giornale di Sicilia” di quella stessa mattina era uscito in edicola con una lunga intervista al presidente della Regione rilasciata il giorno precedente. Incalzato dalle domande di Giovanni Pepi, Mattarella rispondeva con la consueta concretezza. La giunta di transizione Dc-Psi-Pri-Psdi era in crisi e si stava cercando di capire se la nuova, che doveva nascere, avrebbe potuto vedere nuovamente un ruolo attivo dei comunisti. Nel 1978, infatti, Mattarella aveva guidato un governo regionale con il coinvolgimento esterno del Partito Comunista: un fatto assolutamente nuovo per l’Italia. E la giunta era caduta proprio per il ripensamento dei comunisti siciliani.
Il giornalista riportò a Mattarella le parole del responsabile enti locali della Dc dell’epoca, Antonio Gava. Quest’ultimo aveva subordinato il futuro della collaborazione con il Pci nella giunta regionale siciliana alle conclusioni dell’imminente congresso democristiano. Il congresso doveva decidere se proseguire o meno la linea della solidarietà nazionale nel governo centrale. I livelli periferici si sarebbero poi dovuti adeguare. Pepi chiese allora a Mattarella se non ritenesse di sentirsi con le «armi spuntate», in attesa di decisioni che sarebbero state prese a Roma. L’intervistato rispose senza scomporsi:
Il decennio appena iniziato, faceva notare Mattarella, non era nato sotto buoni auspici. Nel 1979 era scoppiata, a seguito della rivoluzione khomeinista in Iran, una vera e propria crisi energetica che aveva creato molti problemi all’economia occidentale mentre il processo di distensione tra Usa e Urss aveva conosciuto una pesante battuta d’arresto. A fine dicembre i carri armati sovietici avevano invaso l’Afghanistan e in questo clima difficile l’Italia si apprestava, dopo scontri e polemiche, a ospitare sul proprio territorio le testate nucleari della Nato, i cosiddetti “euromissili” (istallati successivamente nella base siciliana di Comiso). Di fronte a questa pesante situazione, ribadiva Mattarella, in Sicilia c’era bisogno di un governo stabile ed efficace:
La situazione della Sicilia era particolarmente difficile, perché l’isola scontava ancora, rispetto ad altre Regioni meridionali,
Non mancò nell’intervista un riferimento alla mafia. Il cardinale di Palermo, Salvatore Pappalardo, aveva da poco pubblicato una lettera pastorale, intitolata La persona umana e il diritto alla vita. Riflessioni per l’Avvento 1979, nella quale prendeva di petto non solo gli appartenenti ai clan mafiosi, ma puntava anche il dito sulla cosiddetta zona grigia, sul conformismo diffuso, sulla mancanza di coraggio, sul rifiuto della legalità, sul clientelismo, sulle complicità implicite: tutti fattori che costituivano il retroterra per la formazione della cultura mafiosa.
La moglie del presidente, la signora Irma Chiazzese, non si sente un granché. Un leggero malore che ha finito per rallentare tutta la famiglia. Il piccolo gruppo termina in fretta i preparativi e finalmente si mette in moto. In genere i Mattarella frequentano la parrocchia di Santa Lucia, a un passo dall’Ucciardone, ma sono invitati a pranzo da amici che abitano in un’altra zona. E così il programma è cambiato. La meta è la chiesa di Francesco di Paola, a circa due chilometri da casa.
Quella domenica il presidente, dimissionario dopo una crisi di governo regionale, è senza scorta. Il delicato incarico che ricopre in Sicilia lo espone a pressioni e minacce di ogni tipo e l’anno che si è appena chiuso ha fatto contare, nella sola Palermo, più di cinquanta omicidi di mafia. In questa lista sterminata di morti ammazzati non ci sono solo picciotti appartenenti a bande rivali. Cosa Nostra ha puntato le armi in alto: contro il giornalista Mario Francese, indagatore coraggioso dei misteri mafiosi, contro il giudice Cesare Terranova, ex deputato della Sinistra Indipendente, ucciso insieme al maresciallo di polizia Lenin Mancuso, contro il capo della squadra mobile Boris Giuliano, energico ed efficace investigatore. Ma tra i morti eccellenti di Palermo del 1979 c’è anche il segretario provinciale della Dc, Michele Reina, andreottiano e sostenitore dell’apertura a sinistra. Il primo politico di rilievo assassinato dalla mafia.
Una mafia che in quello stesso anno lascia sanguinose impronte anche lontano dalla Sicilia, in un oscuro intreccio con poteri occulti, servizi deviati, bande criminali e uomini d’affari. Basta pensare all’omicidio di Giorgio Ambrosoli, l’integerrimo liquidatore della Banca Privata Italiana, un istituto bancario sotto il controllo di Michele Sindona, personaggio a cavallo tra Cosa Nostra e ambienti italiani e stranieri della politica, della finanza e della massoneria. O all’uccisione di Mino Pecorelli, il discusso giornalista depositario di torbidi segreti sulle trame dei potenti italiani. Inoltre, in tutto il Paese gli uomini delle istituzioni sono a rischio, potenziali obbiettivi del terrorismo politico, rosso o nero, che ha già sperimentato sul campo tutta la sua micidiale capacità operativa.
Mattarella queste cose le sa. Ha vissuto sulla sua pelle, con trepidazione e dolore, il rapimento e l’assassinio del suo maestro e amico, Aldo Moro. Ha partecipato ai funerali di Boris Giuliano e del giudice Terranova, due servitori dello Stato che la mafia la conoscevano e la combattevano sul serio; è toccato a lui commemorare, in piazza e all’Assemblea Siciliana, il collega di partito Michele Reina. Ma, nonostante tutto, nei giorni di festa ha l’abitudine di congedare gli agenti assegnatigli per la protezione. «Hanno diritto anche loro», spiega, «di passare le festività con la famiglia». Anche se agli amici più intimi ha confidato: «Se vogliono ammazzarmi, lo fanno egualmente»
Il killer e i complici, che hanno seguito per settimane i suoi spostamenti, annotando abitudini, orari e percorsi, sanno che quella domenica Mattarella sarà senza scorta. Sanno anche che per loro sarà maledettamente più facile ammazzare un uomo pubblico, simbolo del rinnovamento politico siciliano, quando si troverà – totalmente indifeso – in un momento del tutto privato, intimo, familiare. La persona che si parerà loro davanti quando sarà ora di premere il grilletto non sarà un politico o un esponente delle istituzioni, ma un marito e un padre affettuoso che, come tanti altri, esce di casa nell’ultimo giorno delle vacanze natalizie per andare a messa insieme alla famiglia. E che cosa importa se Piersanti ha solo quarantaquattro anni, la moglie quarantadue, il figlio Bernardo appena venti e se l’adorata secondogenita Maria ha da pochi giorni festeggiato il diciottesimo compleanno, a casa, con amici e parenti, ballando fiera con il suo papà? Che peso può avere nelle logiche di un’organizzazione criminale il fatto che i Mattarella sono una famiglia unita e felice, con tanta voglia di continuare a esserlo? Non conta nulla – o meno di nulla – se Irma e Piersanti si amano come il primo giorno in cui si sono incontrati, se sognano di invecchiare insieme, se vogliono godersi ancora per lunghi anni la tenerezza reciproca, l’affetto dei figli e i futuri nipotini.
Questi sono pensieri che non possono e non devono sfiorare la mente di un criminale. Il killer deve rimuovere dalla sua coscienza e dal suo cuore ogni traccia, anche minima, di umanità. «Era proprio un robot, che sparava come se sparasse a una pietra o a una sedia», testimoniò la vedova Mattarella in tribunale. Robot, ossia, etimologicamente, macchina che svolge lavori “pesanti” al posto dell’uomo.
La famiglia Mattarella si avvia verso il garage, a pochi metri dal portone di casa. Mancano ormai pochi minuti all’una e il gruppo si divide: Piersanti e il figlio scendono in garage per la piccola rampa. La moglie del presidente, la figlia e la suocera attendono sul marciapiede accanto al cancello, chiacchierando. È lì che gli occhi di Irma incrociano quelli di un giovane poco più che ventenne, un po’ tarchiato, con un giubbotto celeste e il cappuccio calato sulla testa, che le si para davanti con una strana andatura, quasi a balzi, per poi infilarsi nel cortile del bar attiguo. Quel viso un po’ tondo, dalla carnagione chiara e le gote arrossate, le si stampa per sempre nella mente. «Aveva occhi di ghiaccio», ricorderà in più occasioni. Così come le rimarrà impressa una smorfia, un ghigno, non si capisce se di sforzo, di tensione o di giubilo, che appare sul volto del killer appena compiuta la sua missione di morte.
Piersanti si mette alla guida della sua 132 blu. Bernardo non sale. Rimane di sotto per chiudere la porta del box. Prima di scendere ha notato distrattamente, a pochi metri dal cancello, una 127 bianca in sosta sul marciapiede con due uomini a bordo.
Lo spazio di manovra all’interno del garage è piuttosto esiguo. L’automobile percorre la rampa a marcia indietro. Poi si arresta sul passo carrabile per far salire la famiglia. Irma si sistema davanti, accanto al marito. Maria e la nonna dietro. Sono pochi attimi, lo spazio di un paio di respiri prima dell’orrore e della tragedia.
Maria sta parlottando con la nonna. Sente un gran botto, si gira di scatto e vede i cristalli del finestrino anteriore andare in frantumi: «C’era la canna nera di una pistola diretta contro papà, sparava. Lui si è reclinato sulle gambe di mamma… Il killer ha fatto il giro della macchina e ha continuato a sparare dall’altra parte».
Da un’altra prospettiva, dal fondo della rampa, Bernardo scorge un giovane con un giubbotto celeste che si accosta al finestrino del padre, si china leggermente, prova con forza ad aprire lo sportello senza riuscirci. Allora tira fuori un revolver, una micidiale calibro 38, e fa fuoco. Bernardo ricorda una sequenza imprecisata di colpi e un grido soffocato del padre. Paralizzato dall’orrore, riesce a seguire con gli occhi il sicario che si avvicina alla 127 scambiando parole e gesti concitati con il complice. L’uomo in macchina consegna qualcosa nelle mani del killer. Le indagini stabiliranno che la prima pistola si è inceppata e che il giovane con il giubbotto celeste se n’è fatta dare una seconda.
Il sicario fa un rapido dietrofront. Si accosta di nuovo alla macchina del presidente della Regione, stavolta dal lato dove siede Irma. Ha come un attimo di esitazione quando vede la moglie che cerca disperatamente di fare scudo con le mani al marito, ma l’ordine ricevuto è tassativo: Mattarella deve morire. Il killer si sposta, prende la mira dal finestrino posteriore e spara ancora.
Racconta la moglie alla polizia subito dopo l’omicidio: «Non so come sia successo. Ma lui [il killer, nda] se n’è andato. L’ho seguito con gli occhi, mi è sembrato che fosse quasi entrato in macchina. Stringevo Piersanti e guardavo quell’auto sperando che il Signore li facesse andare via. E invece no: il complice, quello alla guida, ha fatto dei gestacci, proprio come se gridasse all’assassino di tornare a sparare. E lui è venuto di nuovo verso di noi. I suoi occhi fissi sui miei, ha sparato l’ultimo colpo».
Irma è rimasta leggermente ferita a una mano, ma quasi non se ne accorge. Carezza il marito riverso su di lei ormai in stato di incoscienza, in una pozza di sangue. Il killer saltella, ancora, in una grottesca danza di morte. Il suo viso si è contratto in una smorfia beffarda mentre, quasi senza fretta, si avvia verso la 127 targata Palermo che lo aspetta con il motore acceso. L’utilitaria sgomma e parte di corsa, dileguandosi in direzione di piazza Politeama. Tutta la scena è stata seguita dall’alto dalla collaboratrice domestica della famiglia Mattarella, la signora Giovanna, che era affacciata alla finestra. Anche lei è rimasta colpita dallo strano modo di camminare dell’assassino.
Racconta oggi Maria con voce tranquilla, ma con lo sguardo velato di tristezza: «Ne abbiamo discusso tante volte con mamma. E abbiamo concluso che è stato un bene che ci fossimo trovati tutti insieme in quel momento, con papà. È come se lo avessimo accompagnato fino alla fine. Non abbiamo mai pensato: “Sarebbe stato meglio non essere lì, non assistere alla scena della sua morte”».
Accorrono i primi passanti, qualcuno esce di corsa dal bar che si trova tra l’abitazione dei Mattarella e il garage. Proprio dal telefono di quel bar Bernardo riesce, in stato di trance, a chiamare il 113. Una seconda telefonata è per lo zio Sergio, il fratello minore di Piersanti, che abita anche lui a via della Libertà, a un paio di isolati dal luogo dell’attentato. Sopraffatto dal dolore e dallo shock, Bernardo non riesce a dirgli tutta la verità: «Zio, corri giù, c’è stato un incidente a papà». Sergio scende subito in strada, preoccupato. La scena che gli si para davanti, con quell’auto crivellata di colpi e piena di sangue, è violenta, allucinante, insostenibile. L’ambulanza tarda ad arrivare, sul luogo è però giunta una volante della polizia. C’è anche un medico, Orietto Giuffré, amico dei Mattarella, che si trovava lì di passaggio. Aiuta i familiari a caricare Piersanti, in agonia, sulla volante. A bordo sale anche Sergio, davanti, mentre il dottor Giuffré si sistema dietro, accanto al presidente. Lo accompagnano per l’ultimo viaggio, a sirene spiegate, verso il pronto soccorso di Villa Sofia. Non è un tragitto lungo ma le speranze di sopravvivenza del presidente si assottigliano. Sergio ricorda ancora l’espressione sempre più sconfortata di Giuffré e la voce concitata proveniente dalla radio della polizia: «C’è stato un attentato a via della Libertà… Non sappiamo se si tratti di un giudice o del presidente della Regione… ». E il poliziotto a bordo che quasi urla: «Confermiamo, è stato colpito il presidente della Regione».
Piersanti non ha mai ripreso conoscenza. Anche se qualche giornale scrive, romanzando, che prima di morire avrebbe sussurrato parole riferite all’adorata moglie: «Non dite nulla a Irma, non fatele sapere». All’arrivo all’ospedale il ferito viene caricato in barella e portato di corsa dal medico di guardia che prova subito a rianimarlo con un massaggio cardiaco. Per il presidente della Regione Sicilia, raggiunto da sei pallottole alla tempia, alle spalle, al petto, al fianco destro, non c’è scampo. Il suo giovane cuore si ferma sette minuti dopo l’ingresso in quell’ospedale. L’autopsia rivelerà che già i primi colpi sono stati fatali. È Sergio, affranto, a comunicare alla folla che si è concentrata fuori dall’ospedale che «non c’è più nulla da fare».
Nella chiesa di San Francesco di Paola la messa dell’Epifania si è appena conclusa: i fedeli, ancora ignari dell’attentato, sciamano festosi verso l’uscita. Il vangelo di Matteo ha appena ricordato la storia dei magi, venuti da Oriente, e la loro «gioia grandissima» nell’assistere alla manifestazione di Dio in quel bambinello nella grotta. Ma per la famiglia Mattarella il Signore quel giorno si è manifestato sotto il simbolo misterioso e dolente del legno della Croce.
In ospedale si allestisce una prima provvisoria camera ardente che diventa subito meta di parenti, amici e autorità cittadine. Ad accogliere tutti c’è il fratello Sergio, con il golf ancora sporco di sangue. Al suo fianco, affranta, sua moglie Marisa, sorella minore di Irma. Arrivano il presidente dell’Assemblea Siciliana il comunista Michelangelo Russo, il segretario della Dc regionale Rosario Nicoletti, particolarmente provato, e quello del Pci Gianni Parisi. Sfilano davanti alla salma deputati regionali di tutti i partiti, leader sindacali, gli amici del “Gruppo politica”, la corrente di giovani professorini fondata da Mattarella. Si affacciano costernati il questore, il prefetto, il comandante provinciale dei carabinieri.
Entrano trafelati anche due agenti della scorta del presidente: sono sconvolti. Il più giovane dei due ha ancora sotto braccio la paletta rossa con cui si è fatto largo tra le auto per raggiungere rapidamente l’ospedale: alla vista del corpo senza vita del suo presidente quasi sviene per l’emozione e viene portato via a braccio dai colleghi.
La gravissima notizia dell’assassinio di Piersanti Mattarella fa subito il giro dell’Italia e del mondo. “L’Ora”, il giornale progressista di Palermo, esce nel pomeriggio in edizione straordinaria, consegnando alla città una sequenza di immagini crude e dolorose. Due fotografi del quotidiano, Letizia Battaglia e Franco Zecchin, si trovavano per caso nei pressi di via della Libertà. Sentiti gli spari, sono accorsi sul luogo dell’attentato. In una foto si scorge la signora Mattarella di spalle, ancora dentro la macchina, che aiuta il cognato Sergio a far uscire dall’abitacolo il corpo del marito.
I sindacati confederali siciliani, Cgil, Cisl e Uil, proclamano immediatamente uno sciopero generale con corteo a Palermo per il giorno successivo, mentre i lavoratori di tutta Italia sono invitati a incrociare le braccia per un quarto d’ora in segno di protesta contro la violenza. L’uccisione del presidente della Regione siciliana è un fatto senza precedenti. Nell’Italia di quegli anni, insanguinata dal terrorismo e dalla mafia, attentati e uccisioni sono quasi quotidiani. E talvolta si corre il rischio di forme di assuefazione alla violenza. Non è questo il caso. Sconcerto, sdegno e commozione si diffondono rapidamente in tutto il Paese. Colpisce la personalità del giovane presidente ucciso, la cui opera di rinnovamento in un contesto difficile come quello siciliano aveva suscitato simpatia. Impressiona la gravità del nuovo attacco portato al cuore dello Stato, a poco meno di due anni dal rapimento e dall’assassinio di Aldo Moro, a cui Mattarella era politicamente e umanamente legato. Turbano le modalità, insolite e crudeli, dell’omicidio.
Da Roma si fa sentire forte la voce del presidente della Repubblica Sandro Pertini, che aveva conosciuto da vicino Piersanti, in novembre, durante una visita di tre giorni in Sicilia. Era stato Mattarella a invitarlo. E dopo quella visita Pertini si era iscritto nella lunga lista dei simpatizzanti del giovane politico siciliano. In un messaggio alla vedova, il presidente scrive di piangere «l’uomo giusto e coraggioso di cui ho conosciuto e apprezzato […] l’ingegno e le grandi qualità umane, civili e politiche». Il capo dello Stato scrive anche al segretario nazionale della Dc, Benigno Zaccagnini, rilevando che l’omicidio Mattarella «è un altro pesante tributo di sangue che la Dc paga alla difesa della Repubblica e dell’ordine democratico contro ogni tipo di criminalità eversiva».
Subito dopo parla il presidente del Consiglio Francesco Cossiga. Si dice convinto che «le forze dello Stato, con la solidarietà e l’appoggio fattivo di tutti i cittadini, non lasceranno impunito l’assassinio di Mattarella, assicurando alla giustizia esecutori e mandanti». Parole che purtroppo saranno smentite – almeno parzialmente – negli anni successivi.
Messaggi di condanna per l’efferato omicidio e di solidarietà alla famiglia arrivano anche dai presidenti di Camera e Senato, Nilde Iotti e Amintore Fanfani. Il segretario della Dc Benigno Zaccagnini si trova a casa, a Ravenna, indisposto. Vorrebbe partire subito per Palermo, ma le condizioni fisiche non glielo permettono. La notizia della morte del giovane amico riapre una ferita dolorosa: Zaccagnini non si è mai ripreso dall’uccisione di Moro. Nel suo messaggio tiene a ricordare che Piersanti «è stato uno dei giovani più vicini e più stimati da Aldo Moro, di cui condivise sempre visione e impegno politico». E ora ha condiviso con l’antico maestro il tragico destino. Per la Dc partono alla volta di Palermo il presidente del consiglio nazionale Flaminio Piccoli e il vicesegretario Nino Gullotti.
Anche Giovanni Paolo II fa arrivare alla famiglia Mattarella, attraverso il cardinale di Palermo, parole di cordoglio e di conforto. Commosso dall’uccisione di quel giovane presidente di Regione anche il presidente della Commissione della Comunità Europea Roy Jenkins, che ha sperimentato proprio a Palermo il vento rinnovatore portato dalla presidenza Mattarella. A via della Libertà, intanto, le forze dell’ordine tengono a bada una piccola folla di curiosi, fotografi e giornalisti ma anche tanti semplici cittadini accorsi a testimoniare vicinanza e dolore. Nelle foto di quel giorno si scorge un giovane, con un cappotto color cammello, che ispeziona l’automobile del presidente Mattarella.
È Piero Grasso, futuro procuratore antimafia e presidente del Senato, all’epoca sostituto procuratore a Palermo. Era lui di turno quel 6 gennaio. E verrà successivamente incaricato delle prime indagini dal procuratore capo Gaetano Costa. Magistrato schivo e irreprensibile, anche Costa sarà ucciso nell’agosto del 1980, in un agguato a Palermo. «Di lui», commentarono i suoi colleghi, «si poteva comprare solo la morte».
Le indagini sulla morte del presidente della Regione vengono avviate in tutte le direzioni e senza risparmiare mezzi. Non si tralascia alcuna pista: quella di mafia, innanzitutto, correlata all’attività di rinnovamento della Regione promossa da Mattarella. Un’attività che sicuramente ha pestato i piedi a qualcuno interessato a mantenere una situazione di opacità, di favoritismi e di inefficienza. Ma a nessuno sfugge nemmeno la inquietante analogia che lega il delitto Mattarella a quello Moro, avvenuto poco meno di due anni prima. Entrambi lavoravano per favorire l’evoluzione in senso compiutamente democratico del Pci attraverso il dialogo, il confronto e l’associazione all’area di governo. Mattarella, addirittura, aveva preceduto il suo maestro nella formazione della sua prima giunta regionale, avvenuta con il voto favorevole dei comunisti siciliani. Una formula, definita di “solidarietà autonomistica”, che anticipava fattivamente la solidarietà nazionale di Moro e Berlinguer. Ma il progetto politico di Moro e di Mattarella aveva molti nemici non solo nella Dc siciliana e nazionale. Erano infatti in molti, in Italia e perfino all’estero, a giudicarlo velleitario e pericoloso.
Polizia e carabinieri organizzano interrogatori, setacciano interi quartieri, effettuano perquisizioni e posti di blocco in tutta l’isola. Vengono ascoltati testimoni, fermati e interrogati militanti di estrema destra ed estrema sinistra. Vertici convulsi si svolgono tra procura, questura e prefettura. Alla polizia arriva una telefonata anonima. Un uomo racconta di aver visto due persone uscire dalla 127 bianca in via De Cristoforis, a meno di un chilometro e mezzo dal luogo della sparatoria. L’auto, al vaglio degli inquirenti, ha una targa falsa, costruita con la giustapposizione di pezzi di due targhe trafugate; risulta rubata a Palermo, in via de’ Cosmi, la sera prima del delitto: il proprietario l’aveva lasciata un attimo in sosta in seconda fila con le chiavi attaccate al quadro. Secondo l’anonimo, i due giovani sarebbero entrati in un androne di un palazzo per cambiarsi d’abito. Successivamente sarebbero saliti su una Fiat 850 grigia, guidata da un terzo complice. Il testimone fornisce perfino la targa. Sembra un’ottima pista ma, rintracciato e interrogato l’ignaro proprietario della 850, i poliziotti si rendono conto che si tratta di un clamoroso falso.
Gli inquirenti ascoltano subito la vedova Mattarella – appena tornata dal centro traumatologico dell’Inail, dove le hanno medicato la mano ferita – i figli e la collaboratrice domestica. Le loro testimonianze permettono alla polizia di diffondere un identikit del killer, ritratto con e senza occhiali.
Arrivano anche le prime rivendicazioni telefoniche. Sono però tutte successive alla diffusione in tv della notizia della morte del presidente e, per questo, devono essere vagliate con grande attenzione. La prima è alle 14.55. Un giovane telefona alla sede palermitana dell’Ansa. Ha una voce insicura, dice di parlare a nome dei Nuclei Fascisti Rivoluzionari. Scandisce: «Rivendichiamo l’uccisione dell’onorevole Mattarella in onore dei caduti di Acca Larenzia a Roma».
I caduti di Acca Larenzia – madre adottiva di Romolo e Remo – dicono poco o nulla ai giornalisti palermitani. Fanno subito ricerche e alla fine collegano quel nome mitologico a un grave e recente fatto di sangue avvenuto nella capitale giusto due anni prima. Il 7 gennaio del 1978, infatti, due ragazzi del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, erano stati uccisi da estremisti di sinistra in un agguato davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano in via Acca Larenzia, nel quartiere Tuscolano. Un terzo giovanissimo militante missino, Stefano Recchioni, era morto poche ore dopo, colpito da un proiettile sparato da un ufficiale dei carabinieri durante violenti tafferugli scoppiati di fronte al luogo della tragedia. Quella strage che aveva coinvolto, sia pure in momenti diversi, militanti di estrema sinistra e forze dell’ordine, segnò per esplicita ammissione dei protagonisti un momento di non ritorno nella recrudescenza dell’azione dei Nuclei Armati Rivoluzionari (Nar), la più micidiale organizzazione terrorista di estrema destra.
Alcune ore più tardi, poco prima delle 19, un uomo telefona alla sede di Messina della “Gazzetta del Sud” per una seconda e opposta rivendicazione. L’uomo dice di parlare a nome delle Brigate Rosse e annuncia il rilascio imminente di un comunicato, che però non verrà mai diramato. Alla redazione romana del “Corriere della Sera” arriva successivamente un’altra telefonata che attribuisce l’uccisione alla colonna palermitana dell’organizzazione terrorista di sinistra “Prima Linea”. Il giorno dopo a “L’Ora” di Palermo, quarta rivendicazione, ancora a firma Br. La macchina del depistaggio è in pieno movimento e gli inquirenti mostrano di non credere troppo a quelle dichiarazioni.
In serata il corpo di Piersanti viene trasportato in via della Libertà. L’ha deciso Irma. Vuole avere ancora il marito accanto, a casa, per l’ultima notte. La salma viene sistemata nello studio del presidente, in mezzo ai libri e alle carte. Le visite di cordoglio non conoscono interruzioni. I presenti ricordano un abbraccio tra la vedova Mattarella e il segretario regionale della Dc Rosario Nicoletti, amico e sostenitore di Piersanti. Erano andati tutti a cena con le mogli, pochi giorni prima, al Charleston: lui, Piersanti, Sergio e un’altra coppia di amici. Avevano parlato anche di politica, del partito e della Sicilia da rinnovare. Nicoletti, impietrito dal dolore, confida a Irma: «Hanno buttato una moneta. O usciva lui o uscivo io». Lei replica premurosamente: «Lei ha figli piccoli, si guardi le spalle, si guardi le spalle…».
Quattro anni dopo, il 17 novembre del 1984, Rosario Nicoletti si suicidò gettandosi dalla finestra della sua abitazione al quarto piano di via Lincoln. Un gesto improvviso e inaspettato le cui reali motivazioni non sono state mai chiarite completamente.
Su un altare improvvisato accanto alla bara del presidente della Regione, monsignor Nino Porcaro, parroco di Santa Lucia e amico di Piersanti, celebra a casa la messa domenicale per la famiglia Mattarella. Come noterà il cardinale Pappalardo nell’omelia funebre, la messa festiva cui Mattarella doveva assistere «fu tramutata in una messa di suffragio ».
Per una sorprendente coincidenza il “Giornale di Sicilia” di quella stessa mattina era uscito in edicola con una lunga intervista al presidente della Regione rilasciata il giorno precedente. Incalzato dalle domande di Giovanni Pepi, Mattarella rispondeva con la consueta concretezza. La giunta di transizione Dc-Psi-Pri-Psdi era in crisi e si stava cercando di capire se la nuova, che doveva nascere, avrebbe potuto vedere nuovamente un ruolo attivo dei comunisti. Nel 1978, infatti, Mattarella aveva guidato un governo regionale con il coinvolgimento esterno del Partito Comunista: un fatto assolutamente nuovo per l’Italia. E la giunta era caduta proprio per il ripensamento dei comunisti siciliani.
Il giornalista riportò a Mattarella le parole del responsabile enti locali della Dc dell’epoca, Antonio Gava. Quest’ultimo aveva subordinato il futuro della collaborazione con il Pci nella giunta regionale siciliana alle conclusioni dell’imminente congresso democristiano. Il congresso doveva decidere se proseguire o meno la linea della solidarietà nazionale nel governo centrale. I livelli periferici si sarebbero poi dovuti adeguare. Pepi chiese allora a Mattarella se non ritenesse di sentirsi con le «armi spuntate», in attesa di decisioni che sarebbero state prese a Roma. L’intervistato rispose senza scomporsi:
- Al congresso Dc manca solo un mese. Ma qui è necessaria una considerazione più complessiva. Non c’è dubbio, le armi possono apparire spuntate. I nodi politici ci sono e sono grossi, legati a scadenze, che del resto erano prevedibili, che riguardano la Dc ma non solo la Dc. Mi auguro che possano sciogliersi nel minor tempo possibile al di là di ciò che Gava ha detto.
Il decennio appena iniziato, faceva notare Mattarella, non era nato sotto buoni auspici. Nel 1979 era scoppiata, a seguito della rivoluzione khomeinista in Iran, una vera e propria crisi energetica che aveva creato molti problemi all’economia occidentale mentre il processo di distensione tra Usa e Urss aveva conosciuto una pesante battuta d’arresto. A fine dicembre i carri armati sovietici avevano invaso l’Afghanistan e in questo clima difficile l’Italia si apprestava, dopo scontri e polemiche, a ospitare sul proprio territorio le testate nucleari della Nato, i cosiddetti “euromissili” (istallati successivamente nella base siciliana di Comiso). Di fronte a questa pesante situazione, ribadiva Mattarella, in Sicilia c’era bisogno di un governo stabile ed efficace:
- Il peggio è cominciato. Il quadro internazionale è politicamente pesante, le conseguenze economiche sono gravi principalmente per le aree depresse come il Mezzogiorno d’Italia. Ma il peggio va affrontato.
La situazione della Sicilia era particolarmente difficile, perché l’isola scontava ancora, rispetto ad altre Regioni meridionali,
- il prezzo di una marginalità geografica che è anche economica. C’è un processo di espansione della struttura industriale del Nord di cui beneficia chi sta più vicino e non la Sicilia. Qui sono aumentati di poco i posti di lavoro nell’industria, si sono ridotti nell’agricoltura, si è avuto un incremento nei servizi e nel turismo. Contemporaneamente è aumentata la domanda dei posti di lavoro, dunque il problema si è aggravato diversamente dai nostri propositi. Da questo punto di vista le incognite dell’80 sono più preoccupanti.
Non mancò nell’intervista un riferimento alla mafia. Il cardinale di Palermo, Salvatore Pappalardo, aveva da poco pubblicato una lettera pastorale, intitolata La persona umana e il diritto alla vita. Riflessioni per l’Avvento 1979, nella quale prendeva di petto non solo gli appartenenti ai clan mafiosi, ma puntava anche il dito sulla cosiddetta zona grigia, sul conformismo diffuso, sulla mancanza di coraggio, sul rifiuto della legalità, sul clientelismo, sulle complicità implicite: tutti fattori che costituivano il retroterra per la formazione della cultura mafiosa.