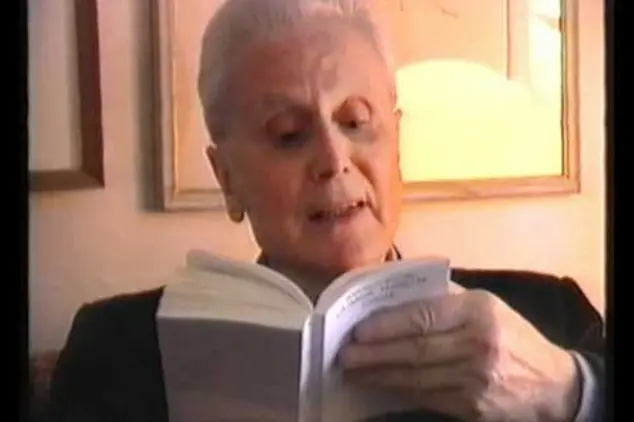PHOTO
Mi ricordo una sera, in casa di Raffaello Baldini, a Milano. Verso l’ora di andar via, quasi sulla porta, si è cominciato a parlare di Dio. Il poeta di Santarcangelo di Romagna, dove tornava soprattutto d’estate, parlava in un sussurro, come certe figure delle sue poesie: disse che Dio lo cercava, lui, che lo cercava senza averne certezza. Me ne ricordo oggi, a dieci anni dalla sua morte (28 marzo 2005). In effetti uno dei fili tenaci della sua poesia, scritta nel dialetto di Santarcangelo, è lo spaesamento, l’essere forestiero anche nel luogo più domestico.
La folla di parlanti di Baldini si sporge di continuo su un abisso. Chi li ascolta, questi parlanti ingenui, che domandano tenacemente qualcuno che li corrisponda? Alcuni dei testi di Baldini, lungo tutta la sua storia poetica, sono delle ipotesi su ciò che non si vede, su ciò che non si sa e non si può sapere e di cui, perciò, si parla, si continua a dire, inciampandovi. In Furistìr c’è una poesia, Mètt (“Metti”), che immagina: «Mètt ch’e’ vénga la féin de mònd…» e alla fine si chiede: «u n gn’è piò gnént, e at tótt che schéur e’ témp / l’andarà ancòura avènti? da par léu? / e do ch’ l’andrà?» (“non c’è più niente, e in tutto quel buio il tempo / andrà ancora avanti? da solo? / e dove andrà?”). Dio è la grande incognita di questa scrittura, una poesia orale e teatrale che si arrampica sopra le voci di infiniti locutori come a tentare tutti i possibili pensieri, le connessioni più segrete, i ricordi più riposti.
L’amore, guardato soprattutto da personaggi maschili, è il punto misterioso, culminante di vite spesso pallide, comicamente o tragicamente sospese. Dany, dall’ultima raccolta del poeta (Intercity, uscita da Einaudi nel 2003), è una delle più belle poesie sull’amore che si ricordino: è il racconto di un uomo sposato, che si innamora teneramente di una ragazza più giovane, che ha timore a toccarla, che si incanta con lei e che la vede portata via da un male implacabile. Un amore sbagliato, si chiede? di cui chiedere perdono? per cui lei è stata punita? In questo testo come altrove compare un sacerdote, compare la chiesa del paese, la preghiera: il borgo, il luogo dell’accasamento, la stessa fede sono i ‘posti’ dove un filo di freddo metafisico bracca il parlante (e così è del dialetto). Sono tentazioni quelle che ci vengono a cercare, dice il monologante di Un susórr (“Un sussurro”, da cui cito in traduzione italiana): “quello è un momento, al buio, ci sei solo tu, / e ti pare di sentire una voce, uno che ti dice / piano, in un sussurro: / non c’è neanche l’inferno, non c’è niente” («u n gn’è gnénca l’inféran, u n gn’è gnént»).
Nulla termina in queste parlate. E il poeta (un poeta non solo per filologi, ma popolare) è tutti insieme i suoi parlanti, i loro interrogativi ansiosi, sperduti, in cerca della compassione della sera; quella di cui parla un’altra poesia di Intercity che cito in traduzione: “è nell’aria, è una cosa, ecco, è / della compassione, sì, è come se la sera / abbia compassione, / lei, la sera, – di che? di chi? di tutto”.
La folla di parlanti di Baldini si sporge di continuo su un abisso. Chi li ascolta, questi parlanti ingenui, che domandano tenacemente qualcuno che li corrisponda? Alcuni dei testi di Baldini, lungo tutta la sua storia poetica, sono delle ipotesi su ciò che non si vede, su ciò che non si sa e non si può sapere e di cui, perciò, si parla, si continua a dire, inciampandovi. In Furistìr c’è una poesia, Mètt (“Metti”), che immagina: «Mètt ch’e’ vénga la féin de mònd…» e alla fine si chiede: «u n gn’è piò gnént, e at tótt che schéur e’ témp / l’andarà ancòura avènti? da par léu? / e do ch’ l’andrà?» (“non c’è più niente, e in tutto quel buio il tempo / andrà ancora avanti? da solo? / e dove andrà?”). Dio è la grande incognita di questa scrittura, una poesia orale e teatrale che si arrampica sopra le voci di infiniti locutori come a tentare tutti i possibili pensieri, le connessioni più segrete, i ricordi più riposti.
L’amore, guardato soprattutto da personaggi maschili, è il punto misterioso, culminante di vite spesso pallide, comicamente o tragicamente sospese. Dany, dall’ultima raccolta del poeta (Intercity, uscita da Einaudi nel 2003), è una delle più belle poesie sull’amore che si ricordino: è il racconto di un uomo sposato, che si innamora teneramente di una ragazza più giovane, che ha timore a toccarla, che si incanta con lei e che la vede portata via da un male implacabile. Un amore sbagliato, si chiede? di cui chiedere perdono? per cui lei è stata punita? In questo testo come altrove compare un sacerdote, compare la chiesa del paese, la preghiera: il borgo, il luogo dell’accasamento, la stessa fede sono i ‘posti’ dove un filo di freddo metafisico bracca il parlante (e così è del dialetto). Sono tentazioni quelle che ci vengono a cercare, dice il monologante di Un susórr (“Un sussurro”, da cui cito in traduzione italiana): “quello è un momento, al buio, ci sei solo tu, / e ti pare di sentire una voce, uno che ti dice / piano, in un sussurro: / non c’è neanche l’inferno, non c’è niente” («u n gn’è gnénca l’inféran, u n gn’è gnént»).
Nulla termina in queste parlate. E il poeta (un poeta non solo per filologi, ma popolare) è tutti insieme i suoi parlanti, i loro interrogativi ansiosi, sperduti, in cerca della compassione della sera; quella di cui parla un’altra poesia di Intercity che cito in traduzione: “è nell’aria, è una cosa, ecco, è / della compassione, sì, è come se la sera / abbia compassione, / lei, la sera, – di che? di chi? di tutto”.