PHOTO
Come mai ha sentito l’esigenza di scrivere questo libro?
«Credo che il tema sia molto attuale. Al di là della parola anglosassone che non mi piace, ha a che fare con la quotidianità delle nostre giornate: c’è da decidere se vivere una vita piena o viverla da spettatore. L’esigenza era far capire che se tutti vivono pienamente la propria vita e fanno bene quello che sono chiamati a fare, anche egoisticamente c’è una miglioria per tutti. Ritengo che sia un tema poco dibattuto nelle categorie "giuste", perché viene usato spesso in ambito aziendale ed è pieno di "guru" che dicono "fai quello che dico io così le cose cambiano"».
A proposito di questo fenomeno, che negli ultimi anni ha preso la scena sui social network...
«Questo testo vuole entrare in un dibattito più ampio sulla leadership a livello mondiale. Dico che ci sono tante definizioni di leadership quante sono le persone che ne parlano. A me non interessa dire "anche se ti sacrifichi, raggiungerai un obiettivo". L'obiettivo non è aiutare le persone a raggiungere i propri traguardi, ma aiutarle a capire se sono positivi o negativi. Il tema è capire se l'altro è un fine o un mezzo. La leadership di cui parlo io è in controtendenza rispetto a questa visione anglosassone. La mia traduzione di leadership è pienezza, e insisto sul fatto che riguarda tutti».
All’interno di un capitolo racconta esperienze personali difficili. Ripensando a quei momenti, quanto è cambiato e cosa l’ha spinta a superare le insicurezze?
«Nel libro insisto molto sulle umiliazioni e sui conflitti. Nessuno è esente dagli "schiaffoni" che la vita dà. Questi possono diventare un’occasione per una rivincita personale, che per me è negativa, perché è una sorta di vendetta. Oppure possono essere, come cerco di dire, qualcosa che fa maturare. Sono occasioni per crescere e per raggiungere una pienezza che passa inevitabilmente anche attraverso i colpi che la vita ti dà. Quell'atteggiamento immaturo porta a una cattiveria, dove gli altri sono uno strumento, un mezzo e non un fine. Quelle esperienze, invece, hanno fatto maturare in me dolcezza e accoglienza. Mi ricordo quelle umiliazioni con il sorriso, come qualcosa che ha fatto parte di un percorso».
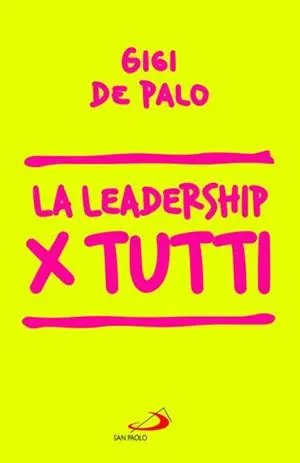
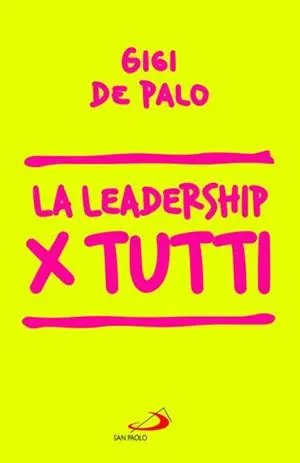
Per lei una singola persona può influenzare molte vite. Che messaggio darebbe a una persona timida, che si sente insignificante, per farle capire il potenziale che ha di incidere positivamente sulla vita degli altri, anche con piccoli gesti?
«Ciascuno nella sua vita ha ambiti in cui è un leader e altri in cui è un "seguace". Anche la persona più timida ha i suoi talenti. L'influenza non è solo "ti faccio vedere come si fa". L'influenza è anche il silenzio. Un po' ci si nasce con la leadership e un po' ci si cresce. Se lei riflette e vede quanto i suoi gesti incidono nella vita degli altri, si rende conto che, anche se crede di non contare, conta molto di più di quanto immagini. Se un infermiere in un ospedale sorride a un paziente, gli cambia la vita. Ognuno ha un'opportunità, e il titolo è "La leadership per tutti" perché ce l'abbiamo tutti. Se io, che sono partito malissimo, sono padre di cinque figli e ho fatto delle cose più grandi di me, è perché ho capito che potevo dare il mio contributo».
Lei riflette sui datori di lavoro che spesso chiedono di separare la vita familiare da quella lavorativa.
«L'unicità della persona è la ricchezza più grande, non la maschera al lavoro o in famiglia. La mia capacità di mediazione nell'associazionismo non nasceva da qualità innate, ma dall'esercizio del vivere con mia moglie, dove devi trovare mediazioni ogni cinque secondi (dice sorridendo, ndr). Quell'esperienza mi è servita a trovare la capacità di mediazione a livello politico e associativo. Noi non ragioniamo a compartimenti stagni; siamo un'unica persona, e questo è un valore aggiunto. Il datore di lavoro assume una persona nella sua interezza, e non è vero che devo lasciare fuori dall'ufficio quello che sono a casa. È nell'equilibrio delle cose: non siamo pezzi di legno».
Nel testo parla della leadership della classe media. Perché, secondo lei, questa leadership che emerge dalla classe media tende a essere sempre sottovalutata od oscurata nella società contemporanea?
«Non è il mondo che la sottovaluta, è la classe media che si sottovaluta. Le persone nella loro testa pensano "basta che porto a casa lo stipendio, basta che faccio il mio". Non vogliono ambire a tanto, ma noi dobbiamo dare tutti il nostro contributo. Se la società non va bene, non è colpa di un singolo, ma di tutti noi che ci stiamo disinteressando. La classe media sottovaluta il potere che ha. Riscoprire questo ruolo, questa forza, questo potere, è una cosa che cambia la storia e la migliora».
Lei afferma che il lavoro può essere uno strumento di appagamento, il che non è così scontato tra le persone. Quante persone lo vedono solo come una fonte di reddito e non di appagamento?
«Pochissime persone riescono a fare il lavoro che hanno sognato. La cosa triste è che questo le demoralizza. Riscoprire il valore sociale e l'impatto del tuo lavoro per il bene comune aiuta a viverlo con più consapevolezza ed energia. Un collaboratore scolastico non è solo uno che lava per terra. Ho conosciuto membri del personale ATA che erano la luce e la gioia dei ragazzi, che davano parole di conforto. Il tuo lavoro assume un connotato molto diverso. Un commesso ha questo ruolo: se rende la scuola pulita, genera bellezza e un comportamento diverso anche nei ragazzi. Se ci pensa bene, capisce il suo impatto. Non esistono lavori di serie A e di serie B. Credo che tutti debbano trovare appagamento nel proprio lavoro, altrimenti si vive una vita triste».




