PHOTO
In un’epoca in cui la velocità social e l’efficienza degli algoritmi minacciano la riflessione, l’uomo deve riscoprire i poteri nascosti del cervello. «Questo, il computer non può darcelo». In occasione dell’uscita del nuovo libro, Dove danzano i pensieri (Piemme), il professor Giulio Maira, fra i più autorevoli neurochirurghi italiani, spiega quali prove dovrà affrontare la nostra mente nell’era digitale.
Qual è stata la sfida più grande nel tradurre dei concetti scientifici complessi in un linguaggio accessibile a tutti?
«È un’abitudine che porto avanti da anni. Da professore, devo spiegare la neurochirurgia ai ragazzi; renderla semplice non è facile. Scrivere per un giornale aumenta la sfida, perché il pubblico è estraneo all'argomento e non deve essere sommerso da termini complicati. Ci vuole sintesi e capacità di usare parole semplici che abbiano però un senso concettualmente importante e che portino un'emozione».
Come possiamo educare le nuove generazioni a mantenere e sviluppare il loro pensiero critico e creativo senza che diventino troppo dipendenti dall’intelligenza artificiale?
«Ci vuole un’educazione all'uso degli strumenti: smartphone, Internet, ChatGPT. Quest’ultimo è utile per velocizzare la ricerca, ma fornisce dati basati solo su ciò che è già noto. Dobbiamo insegnare che la creatività è la ricerca di ciò che è inedito. La mente umana analizza il singolo dato basandosi sulla propria fantasia, creatività ed emozioni. È questa la differenza enorme con l'essere artificiale. Il nostro pensiero è diverso da un algoritmo che produce una fredda analisi di dati».
Con l'aumento delle interazioni digitali e la diminuzione del contatto fisico, non c'è il rischio che la nostra capacità di empatia si indebolisca?
«Assolutamente. L'uomo si è evoluto grazie all'empatia e alla capacità di stare in gruppo. Il rinchiudersi porta a depressione, toglie il contatto fisico. Questo contribuisce allo sviluppo del cervello dei ragazzi, che ha bisogno dell'intelligenza emotiva, bilanciare la razionalità con le sane emozioni. Per questo, stiamo attenti all'abuso dei social, che può portare a una chiusura in sé stessi».
In un'epoca in cui possiamo trovare ogni informazione in un istante, come cambia il ruolo del nostro cervello?
«Il cervello è lento, frutto di un'evoluzione millenaria. La velocità degli smartphone lo riempie di troppi dati, facendolo entrare in confusione. Perde la capacità di analisi. Il cervello è plastico ma si adatta lentamente. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra la sua lentezza e la velocità delle informazioni».


Come valuta il modo in cui comunichiamo oggi, con i social media che spesso privilegiano la rapidità e la superficialità rispetto a un dialogo profondo? Vede un rischio per il nostro sviluppo sociale?
«Sebbene aumenti il numero di laureati, il livello culturale medio si abbassa e si legge meno. L'informazione veloce è un pericolo per la nostra mente. Serve un grande sforzo per trovare un compromesso tra uso delle tecnologie e rispetto delle funzioni del cervello. Per questo è importante la divulgazione scientifica, per informare sui pericoli e le dipendenze. Serve un messaggio formativo per conservare nei ragazzi l'esprit de finesse».
Ritiene che l'eccessiva stimolazione del mondo moderno stia influenzando negativamente anche la nostra capacità di "staccare la spina"?
«Staccare la spina è fondamentale. In realtà, il cervello non si ferma, ma in un momento di ozio attiva il Default Mode Network. Lasciando vagare i pensieri, nasce la contaminazione fra le idee e il colpo di genio, l'intuizione improvvisa. Se riempiamo le giornate, eliminiamo la capacità di sviluppare la creatività».
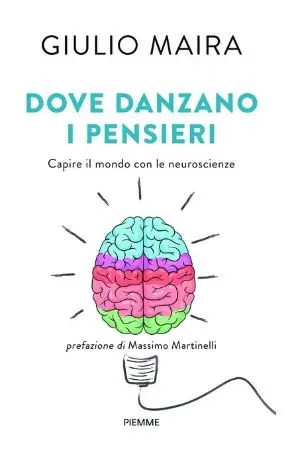
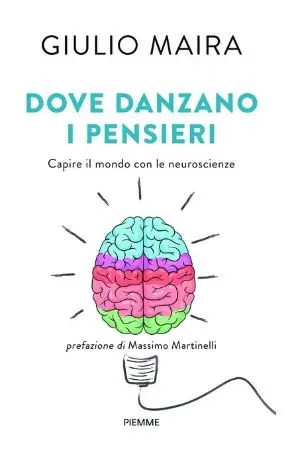
Oggi il ritmo della vita è frenetico. C'è un'incompatibilità tra l'evoluzione lenta del cervello e la velocità della nostra società?
«L'evoluzione della conoscenza e la disponibilità di informazioni sta crescendo esponenzialmente. Andando avanti così, quando arriveremo ad avere i computer quantistici che aumenteranno la capacità di analisi dei dati, il numero di dati a disposizione crescerà enormemente. Ma l'aumento del numero di dati non vuol dire l'aumento della conoscenza».
Si può distinguere tra “informazione” e “conoscenza” per tutelare la nostra capacità di pensiero?
«Bisogna sempre distaccare le due cose: la conoscenza, è il frutto dell'attività di un individuo nel momento in cui elabora qualcuno dei tanti dati, e l'informazione, è il frutto dell'attività di una struttura tecnologica veloce, come il computer. Noi dobbiamo privilegiare il cervello per mantenere sempre il rispetto per questa necessità di tempo di elaborazione, perché il cervello ha bisogno di tempo per elaborare, cioè non solo elabora, ma riesce a produrre pensieri».
Quali sono i segnali che indicano che stiamo perdendo la nostra capacità di pensare in profondità e quali abitudini quotidiane possono aiutarci a recuperarla?
«Lo sviluppo della cultura significa far progredire la conoscenza vera, la creatività, la fantasia, cercando conoscenze sui libri, nella socializzazione, nel confronto delle idee. Leggere tanto ci apre a mondi che altrimenti non conosceremmo mai».



