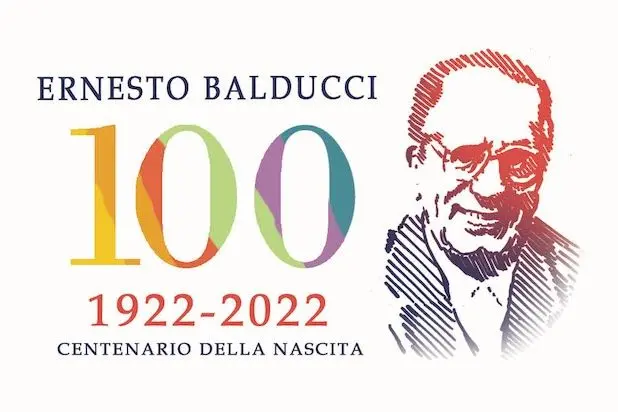PHOTO
«Le chiese intuiscono che la transizione alla civiltà della pace è come un appuntamento storico che Dio ha loro fissato e su cui le giudicherà. Una Chiesa veramente evangelica è come un’obiezione di coscienza piantata da Dio nella carne viva del mondo (...) Secondo alcuni, è già matura la stagione per un concilio ecumenico in cui le chiese si ritrovino non per lanciare un nuovo messaggio al mondo ma per assumersi (...) la responsabilità della sopravvivenza del mondo e, in positivo, dell’avvento della civiltà della pace».
Leggere queste righe tratte dal Il pacifismo ad una svolta, pubblicato in Testimonianze nel 1982, in giorni in cui si confrontano nell’attualità mondiale le parole e gli atteggiamenti, davanti alla guerra in corso così vicina, di papa Francesco e del patriarca Krill ci dà la misura di quanto il centenario della nascita e il trentennale della morte di padre Ernesto Balducci, di cui il 9 aprile 2022 iniziano a Firenze le celebrazioni, cadano in un momento così drammatico e simbolico rendendo di un’attualità sconcertante, se non profetica, le riflessioni di questo padre scolopio che vedeva lontano e per tutta la vita ha parlato di temi diventati urgenti nella nostra attualità: un riflettore puntato sull’importanza della questione ecologica decenni prima della Laudato si’, su come l’arma atomica ha cambiato la prospettiva dell’impegno per la pace, su come essere Chiesa nel mondo diventato piccolo della globalizzazione eppure rimasto diviso della società plurale.
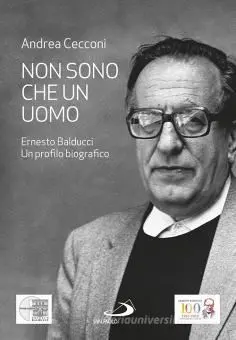
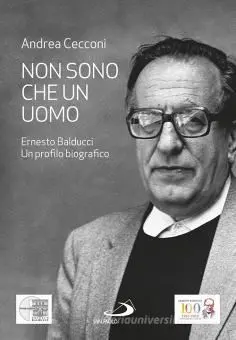
UN SACERDOTE CHE VEDEVA LONTANO
«Non prete del dissenso né del consenso», lo definisce Andrea Cecconi, presidente della Fondazione Balducci, nell’introduzione al suo freschissimo libro San Paolo Non sono che un uomo, Ernesto Balducci. Un profilo biografico, «ma un sacerdote alla ricerca di un nuovo senso della Chiesa nella speranza di un suo rinnovamento profondo secondo le prospettive conciliari. Per questo suo impegno possiamo dire che fu un prete “scomodo”, in particolare nei confronti di chi amava il quieto vivere dello status quo».


UN ANNO ALL'INSEGNA DELLE SUE PAROLE DI PACE
L’inaugurazione dell’anno balducciano si apre sabato 9 aprile alle 10.30 nel salone dei Cinquecento con un incontro dal titolo “Accoglienza e cittadinanza”, cui partecipano tra gli altri il cardinale Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, il teologo Vito Mancuso, Walter Veltroni politico e giornalista, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, padre Sergio Sereni, provinciale italiano dei Padri Scolopi, Severino Saccardi, direttore di Testimonianze, Federico Balocchi, Sindaco di Santa Fiora, Stefania Iacomi, Vicesindaco di Fiesole.
Nel pomeriggio si prosegue, alle 15.30, al Cenacolo di Santa Croce, con la prima sessione del Convegno Se vuoi la pace prepara la pace 2022, "Ernesto Balducci e l'imperativo della pace. Culture e religioni di fronte alla sfida dell'età planetaria", promosso dal Consiglio regionale della Toscana e realizzato dalla rivista Testimonianze in collaborazione con il Comune di Firenze, la Fondazione Ernesto Balducci, l’Opera di Santa Croce, la Fondazione Finanza Etica.
È solo l’inizio di un anno che trova il suo centro il 6 agosto, giorno della nascita di Padre Balducci a Santa Fiora, alle pendici del Monte Amiata. Sarà l’occasione per riscoprire una figura che ha fatto parte integrante del fermento della chiesa fiorentina pre e post conciliare che ha visto confrontarsi e dialogare figure destinate a passare alla storia per le loro voci non scontate: padre Balducci, don Lorenzo Milani, padre David Maria Turoldo, il cardinale Silvano Piovanelli, don Renzo Rossi, don Raffaele Bensi, Giorgio La Pira, solo per citare alcuni, conciliari prima del concilio, fedi robuste ma incarnate nella storia del proprio tempo, e anche oltre, in continuo confronto con un mondo in rapido cambiamento, spesso strette in vita tra la comprensione del Cardinale Elia Dalla Costa e l’incomprensione dell’allora Arcivescovo di Firenze Ermenegildo Florit, ma le cui parole – diverse ma con un denominatore comune - continuano a interrogare credenti e non credenti, tanto più in giorni in cui sono urgenti le domande sulla pace e sul rapporto tra obbedienza, coscienza e reponsabilità.