PHOTO
DALLA PARTE DELL'UMANITÀ FERITA
1. “Prete scomodo”, “prete moderno”, prete “di sinistra” erano alcune delle etichette applicate Padre David Maria Turoldo. Sappiamo che le detestava. Se dovesse riassumerne mistero e ministero in poche parole prima di andare nei dettagli come lo definirebbe?
«Direi che la sua vita è stata una grande avventura «dalla parte dell’uomo», come amava dire, nella storia e nella Chiesa, italiana e non solo italiana, del Novecento. In quel Novecento che ha sofferto e rovesciato dittature, ripensato millenari equilibri ecclesiastici, riproposto con nuova radicalità i dilemmi della ragione e della fede, Turoldo è sempre stato presente. Non vi è stato quasi episodio civile, sociale, ecclesiale del secolo scorso che non lo abbia visto partecipe, spesso protagonista: con la sua oratoria, i suoi scritti, la sua poesia, e prima con il suo concreto fare. Nutrito dalla fiducia immensa di poter rinnovare, Vangelo alla mano, la Chiesa, la società, la cultura. Al di là di ogni definizione faziosa, dalla parte dell’umanità ferita, impoverita, abbandonata; e tra i primi a intravedere che occorreva stabilire un nuovo equilibrio non depredatorio tra umanità e natura, se si volevano assicurare condizioni di vita e di pace sulla terra».
LA VOCAZIONE
2. Era nato durante la prima guerra mondiale in Friuli, che cosa sappiamo di com’è maturata la sua vocazione?
«Turoldo nel corso della sua vita tornò più volte sull’impossibilità di svelare il «mistero» della sua vocazione ma offrì diversi elementi per inquadrarne il sorgere. Nato il 22 novembre 1916 in una famiglia numerosa, in un Friuli devastato dalla prima guerra mondiale, affermava di aver avuto nei genitori e nella fame e povertà sofferti nell’infanzia i suoi primi maestri, il «baricentro» di riferimenti e di orientamenti che lo avrebbero accompagnato nell’intera esistenza. Ricordava con particolare calore l’integrità morale, la dignità, l’innata libertà ereditate dal padre e l’umiltà e la religiosità profonda apprese dalla madre. La povertà, poi, gli aveva insegnato ad apprezzare la bontà delle cose semplici, ma gli aveva instillato anche un precoce spirito di ribellione contro la miseria come elemento depauperante e riduttivo dell’umanità. In una prosa autobiografica, Io non ero un fanciullo, da cui avrebbe tratto nel 1962 il suo unico film, Gli ultimi, il piccolo protagonista, tormentato ed emarginato dal contesto sociale, prorompeva alla fine in un grido di ribellione e di liberazione - "Io andrò a sfamare tutti i ragazzi poveri!" - anticipo di quella lotta contro le ingiustizie che avrebbe contrassegnato tutta l’esistenza di padre David. Il sacerdozio, incontrato anche nella forte e vitale figura del giovane prete del suo paese di origine, Coderno di Sedegliano, gli apparve il modo migliore per "donarsi", per "andare incontro al povero, all’uomo oppresso, all’uomo vittima". "Il sacerdozio – sosteneva – se ha un senso, è nella misura in cui ci si dona all’uomo per liberarlo"».


FRATE SERVITA E SPIRITO IRREQUIETO
3. Ha scelto il convento dei Servi di Maria. Non è strano che abbia optato per una regola anziché per il clero secolare uno che tante volte si è trovato in difficoltà con i superiori per il bisogno di stare tra la gente a predicare più che agli orari del convento?
«La scelta dei Servi di Maria è da legarsi alla frequentazione, ancora fanciullo, del santuario della Madonna delle Grazie di Udine. In un suo ricordo suggestivo padre David ricostruiva la visita a quel santuario dove si trovava – e si trova ancora oggi – un altare dell’Addolorata, vestita di nero, e il suo riconoscere nel volto di quella Madonna, l’immagine di tutte le donne del Friuli, per prima sua madre, le loro lacrime e la loro croce. Dovette dunque avvertire fin da bambino una familiarità con quell’Ordine particolarmente dedito alla devozione mariana a lui cara e che in quegli anni stava vivendo una notevole fioritura. Vi entrò a tredici anni, quando ancora si chiamava Giuseppe (avrebbe poi scelto il nome di David in memoria del re poeta e cantore della Bibbia), e completò i suoi studi nei conventi veneti dei Servi. Non fu mai veramente tentato di lasciarlo, neppure negli anni più duri, in cui fu allontanato dall’Italia dai suoi superiori. In un frammento lirico pubblicato nel volume Io non ho mani esibiva la consapevolezza della propria irrequietezza, come attitudine a interrompere “paci” statiche e infruttuose: “Finalmente ho disturbato/ la quiete di questo convento/ altrove devo fuggire a rompere altre paci”. Avvertiva il vivere in una comunità di confratelli come un elemento di necessario confronto, magari di scontro, ma anche esigenza di condivisione della propria vicenda umana ed ecclesiale. Nei diversi conventi dove soggiornò fu segno di contraddizione ma visse affetti e amicizie profondissimi».
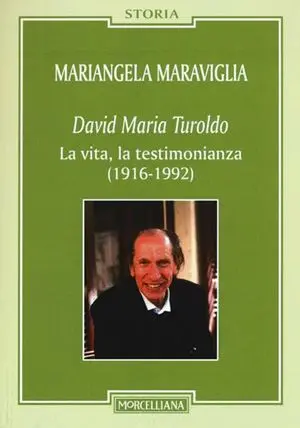
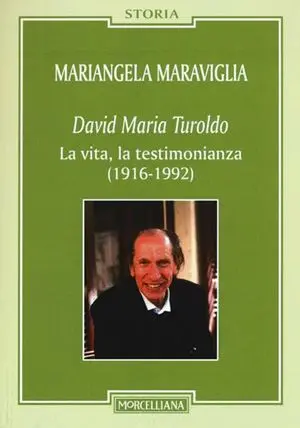
LA RESISTENZA COME "FATTO TOTALE"
4. Considerava la Resistenza, con cui si schierò, non una categoria della storia ma dello spirito. Riusciamo a spiegare che cosa significhi?
La Resistenza, che padre Turoldo visse nella Milano dei primi anni Quaranta insieme all’amico di una vita, il confratello padre Camillo De Piaz, fu un evento centrale della sua vita. Più volte l’avrebbe definita uno "spartiacque" della sua vicenda umana e religiosa. Ne avrebbe parlato come di "un fatto totale", non "soltanto la cacciata dell’invasore tedesco, non […] solo l’abbattimento della dittatura fascista, ma […] la ricerca, il bisogno e l’attesa di un profondo rinnovamento […] spirituale, cioè la speranza di essere uomini buoni e diversi" (conferenza inedita del 1975, in M. Maraviglia, David Maria Turoldo. La vita, la testimonianza (1916-1992), Morcelliana, Brescia 2016, p. 64). Espressioni che ci dicono come la Resistenza non fu per lui solo scelta politica ma fondamento di un nuovo ideale di uomo, prospettiva di rinascita religiosa, morale, civile, politica di un popolo. Dovevano rinascere un’umanità e un popolo nuovo: questo in sintesi lo spirito che animò padre David in quegli anni e negli anni futuri. Nell’immediato significò offerta di aiuto e rifugio ai perseguitati politici nel convento di San Carlo a Corso, dove Turoldo e De Piaz risiedevano; coraggio temerario nella fondazione e divulgazione del foglio clandestino L’Uomo e ancor più nella organizzazione di incontri tra forze politiche antifasciste, anche comuniste, per prospettare le linee della democrazia del futuro. Con i fascisti davanti alla porta e il comando tedesco dei trasporti stabilito nei locali del convento.
TRA LA CORSIA DEI SERVI E IL CHIOSTRO DEI "FOLLI DI DIO"
5. Negli anni Quaranta e Cinquanta ha vissuto prima a Milano e poi a Firenze, due luoghi che in modi diversi hanno respirato istanze di rinnovamento anticipatrici del Concilio. Quanto hanno influito nel percorso di padre Turoldo e viceversa?
«In effetti Milano e Firenze sono state tappe cruciali nel percorso di padre David, che poté inserirsi in realtà vivissime sul piano culturale, ecclesiale, sociale e offrire il suo contributo di libertà e creatività. Milano, dove Turoldo fu inviato nel 1941 per poter frequentare l’Università Cattolica (si laureò in filosofia nel 1946), significò apertura di nuovi orizzonti culturali grazie all’incontro con filosofi e letterati come i suoi docenti Mario Apollonio e Gustavo Bontadini e i compagni di studio Luigi Santucci e Angelo Romanò con i quali tutti condivise la partecipazione attiva alla Resistenza. Negli stessi anni conosceva poeti e personalità della cultura come Carlo Bo, Luciano Erba, l’allora giovanissima Alda Merini, e iniziava a pubblicare i suoi testi poetici. Nel dopoguerra significò la possibilità di entrare in contatto con le voci più aperte del cattolicesimo del tempo e di condividerne la certezza che il cristianesimo poteva e doveva dare il suo contributo alla società da ricostruire. Collaborò, per esempio, con il prete e scrittore don Primo Mazzolari e con i politici che fecero la Costituzione Giuseppe Dossetti e Giuseppe Lazzati. A San Carlo diede vita con Camillo De Piaz alla Corsia dei Servi, centro culturale, libreria, casa editrice, luogo di conferenze, cineforum, di apertura e dialogo anche con scrittori non credenti, addirittura comunisti, come Elio Vittorini, negli anni in cui l’adesione al comunismo veniva condannata con la scomunica. Una prodigiosa vivacità e capacità di “coagulare” persone e pensiero critico. Troppo, in un tempo in cui nella Chiesa ancora si scommetteva sull’uniformità delle voci e delle scelte, e si colpirono personalità di avanguardia come Mazzolari, Lorenzo Milani, Arturo Paoli. Il Sant’Uffizio comandò alle gerarchie dell’Ordine servita di inviare padre David fuori dall’Italia, nel primo di quelli che lui avrebbe considerato dolorosi esili (fu inviato nel 1952 nel convento di Innsbruck ma visse per lo più ospite di un monastero benedettino di Monaco di Baviera). Riuscì a tornare, nel 1954, non a Milano ma a Firenze, nel convento dei Servi dell’Annunziata, e fu l’incontro con la Firenze ricca di fervore del tempo, la città vivacizzata dalle presenze di Giorgio La Pira, di Ernesto Balducci, di Lorenzo Milani. Turoldo partecipò a convegni pubblici e privati, promosse le stesse iniziative culturali avviate a Milano, favorì iniziative di rinnovamento nel convento dei Servi di Maria. Anche lì troppo disturbo per apparati gerarchici che consideravano pericoloso ogni tentativo di riforma e si cullavano in un’immagine di onnipotenza che la secolarizzazione incalzante avrebbe presto mostrato illusoria. Nel 1958 fu il primo tra diverse figure di punta ad essere allontanato in un nuovo esilio (questa volta a Londra, con lunga esperienza di predicazione americana; poté rientrare in Italia nel 1960)».
IL VANGELO E LA VICENDA DI NOMADELFIA
6. Quanto la vicinanza all’esperimento sociale di Nomadelfia di Don Zeno Saltini e quanto altre cose hanno contribuito a incomprensioni con la gerarchia che lo hanno costretto a un lungo peregrinare nel mondo?
«Un altro incontro cruciale nella vita del Servo di Maria fu quello, avvenuto nel 1948, con don Zeno Saltini, che aveva da poco avviato la comunità di Nomadelfia occupando l’ex campo di concentramento di Fossoli (Modena). Quella esperienza di fraternità, realizzata da famiglie o «madri di vocazione» disposte ad accogliere bambini orfani o abbandonati, apparve a Turoldo un modello esemplare di società cristiana realizzata e per alcuni anni ne divenne il massimo sostenitore. Di sicuro venne considerato corresponsabile dell’esperimento di Nomadelfia, tanto più che sette suoi confratelli, tra questi Giovanni Vannucci, decisero di trasferirsi là nel tentativo di dare avvio a una nuova esperienza monastica. Nella complessa vicenda che portò alla chiusura (temporanea) di quella realtà (don Zeno nel febbraio 1952 ricevette dal Sant’Uffizio l’ingiunzione di abbandonarla), anche la figura di padre David risultò compromessa. Tuttavia la città di don Zeno fu solo uno dei numerosi scenari su cui si giocò l’impetuosa vitalità di Turoldo (i motivi degli allontanamenti e delle emarginazioni vanno oltre Nomadelfia, con cui interruppe la collaborazione nel 1952). L’amico scrittore Luigi Santucci stendeva nel 1948 un ritratto efficace del giovane Turoldo, delineandone la coraggiosa e "incontinente schiettezza", il suo "dilapidarsi, senza risparmio" puntando "tutto sul Vangelo". Da quella attitudine evangelica e impetuosa nascevano iniziative suscitatrici di incomprensioni e ingiunzioni che amareggiarono Turoldo, perché, avrebbe ricordato più avanti, era "proprio la Chiesa a impedirti di vivere il Vangelo"».
PREDICAZIONE E POESIA, L'IMPORTANZA DELLA PAROLA
7. Tra i fili conduttori della vita di Turoldo ci sono la predicazione e la poesia, due modi molto diversi di esprimersi. Che cosa ci dicono di lui?
«Predicazione e poesia sono due modi diversi di un un’unica vocazione alla parola che Turoldo avvertì imperiosa nel corso dell’intera vita come espressione della propria testimonianza cristiana. Sia nella predicazione che nella poesia la sua parola assumeva spesso toni e funzione consapevolmente profetici. Suo compito, affermava a più riprese, era il risveglio delle coscienze, il suscitare opposizione all’ingiustizia, la denuncia del "conflitto implacabile tra la realtà com’è e la realtà sognata, invocata, creduta", il dichiarare "la menzogna del mondo": "Profeta non è uno che annuncia il futuro, è colui che in pena denuncia il presente", scriveva in suoi famosi versi, attribuendosi implicitamente il ruolo che gli veniva da più parti riconosciuto. Ma la sua poesia non si caricava soltanto dei toni profetici della denuncia o della esortazione, assumeva anche le coloriture più intime e sofferte della confessione e dell’interrogazione sull’impenetrabile silenzio di Dio, che divenne tema cardine degli ultimi tempi. La sua ultima lirica esprimeva una sorta di incessante ricerca di Dio che non taceva la tentazione dell’incredulità e si consegnava infine alla fede impotente del Cristo morente sulla croce: impotente ma totalmente affidata a un "Tu" inconoscibile e amato. Nella predicazione e nella poesia turoldiana, una vasta platea di ascoltatori e lettori sentì risuonare le proprie speranze, attese, dubbi, interrogazioni. Sono rimasta colpita, in occasione della prematura morte del giornalista David Sassoli, dallo scoprire che il suo nome intero era David Maria come Turoldo, a riprova di quanto alcune generazioni novecentesche si riconoscessero nelle sue parole e in qualche modo lo avvertissero come loro portavoce».
CRISTIANI IN POLITICA E LAICITÀ DELLO STATO
8. Nel fermento tra i primi anni della Repubblica e gli anni Settanta è stato centrale il dibattito sui cristiani in politica, il rapporto tra fede, coscienza civile e laicità dello Stato. Come si collocava Turoldo in questo contesto?
«Turoldo difese sempre la distinzione della Chiesa dalla politica intesa come appoggio a un partito o come ricerca di favori, intendendo così salvaguardare la libertà della Chiesa, la laicità dello Stato, i diritti della coscienza. Tale distinzione lo condusse nell’immediato dopoguerra a prendere le distanze dal “partito cristiano”, a differenza per esempio dell’amico don Primo Mazzolari che vi investì nella speranza, sempre delusa, di un’auspicata “rivoluzione cristiana” a favore dei poveri. Negli anni Settanta e Ottanta la stessa convinzione lo portò a dichiararsi in favore della laicità dello Stato quando, come nel caso del referendum sul divorzio (1974) e sull’aborto (1981), si tentava di imporre per legge una scelta di fede: non era accettabile, sosteneva, che una norma religiosa fosse resa obbligante per vincolo legislativo. La coscienza cristiana, alimentata dalla logica dell’incarnazione di Cristo – cioè di «un Dio che pena/ nel cuore dell’uomo», secondo altri versi turoldiani –, non poteva però essere estranea alla politica intesa in senso alto come impegno nella storia. Dopo il Concilio Vaticano II, che aveva abbattuto i «bastioni» che separavano Chiesa e mondo, la Chiesa poteva a pieno titolo risituarsi all’interno del cammino dell’umanità, riscoprirsi annunciatrice della presenza di Dio per tutti gli uomini, segno di una salvezza che si sarebbe compiute in tempi escatologici, ma che intanto poteva e doveva concretizzarsi nei frutti storici della giustizia e della pace. Ed ecco l’impegno di padre David in prima fila nelle lotte condivise per i diritti dei più poveri in Italia e mondo; la promozione delle voci della teologia della liberazione latinoamericana, esempio di fede vissuta in chiave di prassi liberatrice; l’impegno per la pace come "utopia che porta avanti il mondo"».
LA VERSIONE DEI SALMI
9. Per essere uno poco incline a quello che Mazzolari chiamava “spiritualismo disincarnato” Turoldo ha avuto un interesse particolare per la liturgia: come si conciliano questi due aspetti?
«In un testo che amo e cito molto, un testimone eccellente del tempo come Raniero La Valle ricorda che a Fontanella di Sotto il Monte – il paese di papa Giovanni dove Turoldo riuscì a trasferirsi con una piccola fraternità nel 1964, ultima tappa del suo pellegrinare – "presiedeva fiammeggianti liturgie, in cui si cantavano i Salmi che egli […] aveva tradotto in una lingua non morta e non volgare, canti di liberazione e di imminente speranza, come da nessun’altra parte si cantavano" (R. La Valle, Prima che l’amore finisca. Testimoni per un’altra storia possibile, Ponte alle Grazie, Milano 2003, p. 202). È un testo che risponde da solo alla sua domanda. La liturgia celebrata da padre David non aveva niente a che fare con “spiritualismi disincarnati” ma era tempo festoso di canto e d’incontro, esperienza di vita corale e compartecipata, espressione di un popolo protagonista della storia propria e di tutti. Nella liturgia, in accordo con la costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, Turoldo coglieva la centralità dei Salmi che ritradusse più volte, in collaborazione con Gianfranco Ravasi, perché fossero comprensibili e cantabili dal popolo cristiano. Pregare con gusto e fede, avere "una liturgia più viva e più convincente", come scriveva al suo vescovo Clemente Gaddi, significava vincere i «luoghi comuni» della preghiera come alienazione, rilanciarne la "forza operante e irresistibile"; valorizzarla nella duplice dimensione 'storica' e 'cosmica': del portare a Dio "gli avvenimenti e le gioie degli uomini e di tutte le creature", del colmare l’uomo della presenza divina "per esplodere nel tempo e nella storia con la stessa forza di Dio" (D.M. Turoldo, Preghiera come lotta, in «Servitium», 1981, n. 13, pp. 47-52)».
L'ESSENZA DEL VANGELO
10. Se dovesse individuare i punti di riferimento di Turoldo nella Chiesa del suo tempo, quali citerebbe per primi?
«Senz’altro il Vangelo e la Bibbia. I testimoni degli anni Quaranta – sono riuscita ad ascoltarne alcuni – mi hanno ricordaato come il giovane padre David, fin da quegli anni, leggesse loro il Vangelo quando nessuno lo faceva, per ricavarne una sostanza di vita trasformata, superando una fede ridotta a "devozionismo" e formule vuote. A partire dal Vangelo auspicava, come scriveva al confratello Vannucci nel 1949, la "liberazione del cristianesimo da tutte le coreografie di antica e di recente data", il superamento delle "soprastrutture" e degli "ingombri spirituali" che rendevano "superstiziosi e niente affatto cristiani". Quella "liberazione" sembrò realizzarsi con la riscoperta della Parola di Dio nel Concilio Vaticano II, che fondava un nuovo radicamento e una nuova essenzialità. Bibbia e Vangelo venivano finalmente posti all’attenzione di tutti e approfonditi in gruppi, cenacoli, parrocchie come mai prima nella storia del cattolicesimo. Turoldo non si stancò di portare il suo contributo di predicazione e scrittura alla presentazione e commento di testi dell’Antico e del Nuovo Testamento, come attesta la sua copiosa bibliografia. Magari non sempre con il necessario rigore e approfondimento, come gli rimproverava Camillo De Piaz, ma con grande generosità, creatività, amore per la Parola di Dio».
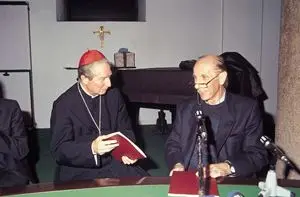
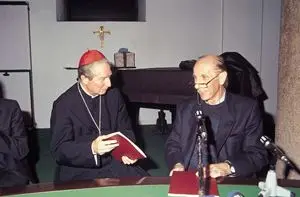
DA SCHUSTER A MARTINI, LE FIGURE DI RIFERIMENTO
È stato spesso incompreso dalle gerarchie ecclesiastiche ma ha anche beneficiato dell’appoggio e dell’amicizia di figure al di sopra di ogni sospetto o che ricoprivano importanti cariche istituzionali.
«Turoldo, anche nei momenti di maggior sofferenza per le emarginazioni subite, ha sempre pensato di lavorare “dentro” la Chiesa, semplicemente non poteva pensare né poteva accettare di esserne collocato in nessun senso “fuori”. È un tratto che lo accomuna a molti altri protagonisti del riformismo cattolico novecentesco, penso a Mazzolari, Paoli, ma anche a una donna fieramente critica come Adriana Zarri. Nella sua vicenda colpisce, e a volte sorprende, la fiducia che seppe guadagnarsi da tante personalità “eccellenti” della Chiesa del suo tempo, segno del calore, della sincerità che comunicava con la sua parola e la sua azione. Negli anni Quaranta fu invitato a collaboratore con il fondatore dell’Università cattolica Agostino Gemelli come assistente ecclesiastico per gli studenti; nel 1943 il cardinal Ildefonso Schuster lo chiamò a "predicare il Vangelo" in duomo a Milano (lo fece ogni domenica per dieci anni); Giovanni Battista Montini sia da arcivescovo a Milano sia da papa gli attestò affetto e stima; nei primi anni Sessanta fu accolto a Bergamo, con franchezza critica ma con grande rispetto, dal vescovo Clemente Gaddi; in quegli stessi anni nacque anche l’amicizia con il segretario di Giovanni XXIII Loris Capovilla (che ha voluto essere sepolto accanto a lui nel cimitero di Fontanella di Sotto il Monte); negli anni Ottanta Carlo Maria Martini gli riaprì le porte del duomo di Milano e in qualche modo lo 'riabilitò' nei confronti dei settori più conservatori, chiedendogli anche perdono, a nome della Chiesa, per il mancato riconoscimento della sua opera. Lo avrebbe poi salutato, celebrandone il funerale l’8 febbraio 1992, offrendone un ritratto di grande vivezza: "Poeta, profeta, disturbatore delle coscienze, uomo di fede, uomo di Dio, amico di tutti gli uomini"».
I TEMI "ULTIMI": DIO, IL DOLORE, LA MORTE
Negli ultimi anni e persino giorni della vita, ormai consumata dal cancro, Turoldo ci ha consegnato versi e riflessioni sul senso del dolore e della morte. In un tempo storico come quello della pandemia in cui l’occidente si sta interrogando su questi temi come mai dalla fine della seconda guerra mondiale, il pensiero di padre David ci consegna qualcosa di utile a interpretare il presente?
«Direi il pensiero e il suo vissuto concreto. Quella che per molti sarebbe stata una stagione di silenzioso raccoglimento in attesa della morte, divenne per Turoldo un altro, estremo, tempo di comunicazione di un messaggio di vita. La malattia divenne invito ad andare "all’essenziale", accogliendo ogni giorno come "un giorno nuovo, che non è mai stato vissuto da nessuno sulla terra", come confessò a Enzo Biagi in un’intervista televisiva. Andare all’essenziale significò per lui concentrarsi sui temi “ultimi” del dolore, della morte, di Dio, senza mai dimenticare quell’esigenza di fraternità, libertà, giustizia, che lo aveva da sempre alimentato. Ormai stremato, volle ancora partecipare alla manifestazione organizzata nel settembre 1991 all’arena di Verona dai movimenti per la pace, commuovendo la platea con le sue parole e la sua poesia. Ancora appassionato "come se il futuro fosse dalla sua parte", avrebbe notato padre Balducci che gli era al fianco: «Egli sapeva che non aveva futuro. Ma si era liberato di sé e respirava col mondo». In questi giorni drammatici, per tanti versi così lontani da quelli condivisi da Turoldo, mi sembra che il suo invito possa essere ancora compreso nel suo valore intatto: un invito a concentrarsi sul senso profondo delle cose, della vita, della fede; a liberarsi di sé e respirare col mondo, nella consapevolezza che «nessuno si salva da solo», secondo le parole indimenticabili di papa Francesco, e che a ognuno è consegnato il compito, esigente e meraviglioso, di rendere accogliente per ogni creatura la terra, la storia, il vivere sociale e quotidiano».





