PHOTO
Erano alcune decine a camminare quella mattina lungo i cantieri dello scalo di Porta Romana, guidati da Pietro Basile di Libera Milano ed Elisa Orlando della Scuola Common – Libera. Cittadini, attivisti, esponenti dell'associazionismo meneghino, studenti, giornalisti: un piccolo gruppo, raccolto tra barriere blu e ruspe, a osservare da vicino un pezzo di città che si trasforma. Non una passeggiata qualsiasi, ma una «passeggiata monitorante», un modo per allenare lo sguardo a leggere i segni urbani, le promesse e le contraddizioni di Milano-Cortina 2026.
Davanti agli escavatori che affondano nella terra, la memoria si intrecciava con la pittura di Umberto Boccioni. Nel 1910, il quadro Officine a Porta Romana immortalava la Milano operaia, la città che cresceva sulle spalle degli operai, tra officine e capannoni. Allora le sirene suonavano a mezzogiorno e centinaia di grembiuli blu uscivano in massa per la pausa pranzo. Oggi, al loro posto, torri, rendering e il Villaggio Olimpico.


«Lo scalo raccontava di una città che non esiste più» spiega Basile. «Era il luogo dove i treni merci si fermavano per rifornire il mercato cittadino. Ora, invece, è diventato terreno di sviluppo immobiliare». Una signora aggiunge un ricordo personale: «Io sono cresciuta qui, tornavo da scuola e vedevo fiumi di operai con la tuta blu. Ogni volta che torno mi sembra di rivederli, anche se al loro posto ora ci sono cantieri e gru».


Camminando lungo le barriere blu, lo stesso colore che ricorre in tutti i cantieri olimpici, i partecipanti notavano i pannelli decorati da street artist. «Non è spontaneismo» osserva Basile, «ma comunicazione di cantiere: serve a rendere accettabile ciò che altrimenti sarebbe percepito come un’invasione».


Dietro quelle palizzate prendono forma sei palazzine, destinate a ospitare 1.400 atleti. I costi stimati inizialmente in 100 milioni sono saliti a 140. «Quaranta milioni in più coperti con soldi pubblici» sottolinea Orlando. «Siamo abituati a leggere i numeri in astratto, ma tra 100 e 140 milioni c’è la differenza tra un asilo costruito o non costruito, tra un reparto ospedaliero aperto o chiuso».
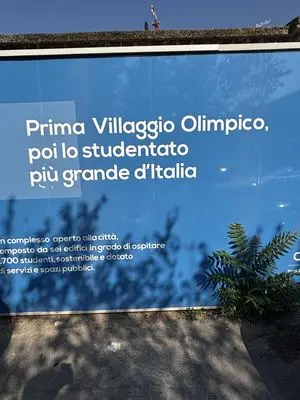
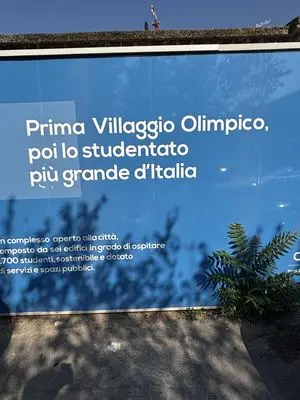
Finita la festa, l’area diventerà il più grande studentato d’Italia, con 1.700 posti letto. Ma la gestione sarà privata. «Non si tratta di edilizia pubblica» chiariva Basile. «Saranno operatori privati a fissare gli affitti. Non sappiamo se gli studenti potranno permetterselo». Una domanda che si riflette sulla più ampia questione dell’eredità olimpica: quali benefici resteranno davvero in mano alla collettività?


Non solo Porta Romana. A Santa Giulia, il Palaitalia da 16mila posti nascerà senza eredità: nessun accordo con basket o pallavolo per utilizzarlo dopo i Giochi. «È un impianto simbolo di questa logica» scrive lavialibera, «grandi opere commissionate a enti privati, sottratte al controllo pubblico, destinate a un futuro incerto».
L’inchiesta della rivista, presentata dalla direttrice Elena Ciccarello, ha mostrato la distanza tra le promesse e la realtà. «La parola sostenibilità compariva 97 volte nel dossier di candidatura» ricordava. «Ma i tradimenti sono evidenti: la nuova pista di bob non prevista, oltre 120 milioni di spesa, ottocento alberi abbattuti, impianti costruiti su terreni fragili. A Cortina si realizza una cabinovia su un’area con una faglia attiva, affidata a una società senza esperienza».


A emergere sono anche i costi sociali. «A Cortina i volontari selezionati non trovano alloggio» raccontava Ciccarello. «Una notte su Airbnb costa tremila euro. Molti dovranno dormire a cento chilometri di distanza e viaggiare due ore ogni giorno. E non sanno nemmeno dove collocare le forze dell’ordine». Questo a fronte di oltre 5 miliardi e 720 milioni di euro di costo dell'evento . Un miliardo e 600 milioni per la realizzazione dei Giochi e altri 4 miliardi e 120 milioni per le opere connesse (il 68% assorbite da 45 opere stradali per un costo che supera i 2 miliardi e 816 milioni di euro totali). La Lombardia da sola assorbe circa la metà delle opere (il 52%) e dei relativi costi (47%)
Milano e le montagne condividono un problema: la mancanza di trasparenza. Il comitato olimpico incaricato di vigilare è stato istituito solo nel 2024. La sua prima relazione, appena quindici pagine, era scritta in caratteri enormi. «Persino il nome del portale di trasparenza è stato sbagliato: Openlinkics invece di OpenOlympics» ironizzava la direttrice.


La camminata si è conclusa davanti a un grande murale che copre le palazzine già completate. Orlando ha offerto la sintesi più efficace: «Se al posto di sei palazzi avessero costruito un parco, una scuola, un centro sanitario pubblico, sarebbe stato perfetto. Invece abbiamo visto cosa è stato scelto. E soprattutto cosa è stato scartato».


Così, i «Cento passi verso le Olimpiadi» si sono rivelati anche cento passi dentro una Milano in bilico, sospesa tra la memoria operaia di Boccioni e un futuro di spazi privatizzati. Una città che rischia di perdere il suo respiro pubblico dietro i colori rassicuranti dei cantieri e i numeri ingannevoli delle promesse.




