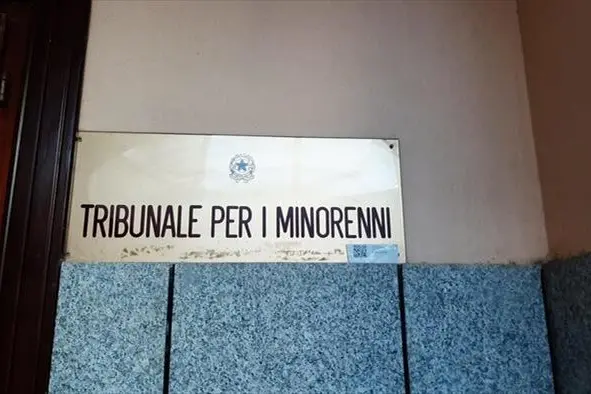PHOTO
«Quando li abbiamo accolti in ateneo, non sapevamo cosa aspettarci. Non loro, non noi. Ma sapevamo che dovevamo provarci». Il professor Giancarlo Tamanza, psicologo clinico e direttore del Servizio di Psicologia Clinica e Forense dell’Università Cattolica di Brescia, racconta così l’inizio di un progetto tanto innovativo quanto controcorrente: “Messa alla prova in Università”, percorso di accompagnamento educativo per otto minori autori di reato, accolti tra le aule e i laboratori di uno dei campus universitari più prestigiosi del Paese.
È un’idea semplice quanto rivoluzionaria: spostare l’esperienza della giustizia minorile da spazi punitivi o marginali a un luogo simbolico e reale di crescita. “Non un parcheggio sociale”, sottolineano gli ideatori, “ma un contesto di apprendimento, bellezza, e relazioni significative”. L’obiettivo non è solo “rieducare”, ma fare fiorire. E per farlo, servono ascolto, metodo e fiducia.
Non solo sanzione, ma possibilità
«Il nostro obiettivo – spiega Tamanza – era duplice: offrire un’occasione di cambiamento concreto ai ragazzi e validare un modello educativo replicabile altrove. Abbiamo voluto capire se l’università, con il suo valore simbolico e relazionale, potesse rappresentare un contesto utile a sostenere processi di riabilitazione e crescita».
I risultati sono stati sorprendenti. «I ragazzi hanno aderito con convinzione, alcuni con fatica, certo, ma tutti con serietà. Nessuno si è sottratto. E molti hanno rivelato risorse inaspettate». Anche il territorio ha risposto con entusiasmo. «Dopo la prima conference pubblica abbiamo ricevuto offerte spontanee di collaborazione da scuole, famiglie, associazioni. Un piccolo movimento di comunità si è attivato attorno a loro».
Il valore di un contesto non stigmatizzante
I ragazzi coinvolti – italiani e stranieri, provenienti da contesti sociali e familiari molto diversi – erano tutti inseriti in un percorso di “messa alla prova” deciso dal Tribunale per i Minorenni. Alcuni venivano da comunità educative, altri erano ai domiciliari. Tutti con una storia penale alle spalle. Ma ciò che conta, spiega Giuliana Tondina, procuratrice capo del Tribunale per i Minorenni di Brescia, «è che non li abbiamo scelti per i loro talenti o per il loro “potenziale di successo”. Li abbiamo scelti perché avevano bisogno. E perché volevamo verificare se, in un contesto così diverso, avrebbero potuto fiorire. Così è stato».
«Molti dei ragazzi del penale – continua Tondina – hanno una profonda sensazione di non appartenere. Non si sentono parte della comunità degli adulti. A volte neanche di quella scolastica o cittadina. L’università rappresenta l’opposto: un luogo di eccellenza, di bellezza, di progettualità. Offrire loro un’esperienza lì significa invitarli dentro, e non respingerli fuori».
Un’esperienza integrata e su misura
Il cuore del progetto è stato un accompagnamento integrato e personalizzato. Ogni ragazzo ha seguito un PEI – Piano Educativo Individualizzato che prevedeva attività diverse: corsi di lingua (inglese e spagnolo), alfabetizzazione informatica, supporto alla ricerca accademica, introduzione alla fotografia creativa. A fianco, sempre, una psicoterapeuta: giovani professioniste della scuola di specializzazione in psicoterapia dell’ateneo, che hanno affiancato ciascun ragazzo con incontri settimanali e una doppia valutazione clinica, iniziale e finale.
«Non era solo un sostegno psicologico – chiarisce Tamanza – ma un vero accompagnamento trasformativo. Abbiamo aiutato ciascuno a identificare due obiettivi realistici di crescita, e li abbiamo sostenuti passo dopo passo. Per molti era la prima volta che un adulto li seguiva con continuità, senza giudicarli».
Camminare insieme: la “trekking pole therapy”
Tra i momenti più significativi, il trekking terapeutico sul lago di Garda, realizzato dalla cooperativa Atea. Sei tappe in sei giorni, da Toscolano Maderno e ritorno, per un totale di cento chilometri.
«Abbiamo usato uno strumento che conosciamo bene: la trekking pole therapy – spiega Nicola Maccioni, responsabile della cooperativa –. Camminare nella natura, con educatori e psicologi, permette ai ragazzi di ascoltarsi, di parlare, di faticare insieme. E la fatica è maestra di introspezione».
«All’inizio – racconta – alcuni erano scettici. Abituati a muoversi solo dal parcheggio a casa, faticavano a capire il senso. Ma dopo il secondo giorno, qualcosa si scioglie. La bellezza del paesaggio, la condivisione, la distanza dalla routine, creano le condizioni per un vero dialogo con sé stessi. E poi c’è l’effetto sorpresa: “Non pensavo di farcela, invece ce l’ho fatta”. È un’emozione potente».
Il reato, la vittima, il rispecchiamento
Alla fine del cammino, i ragazzi sono stati coinvolti in gruppi di parola guidati dai mediatori dell’Istituto di Mediazione Penale. Il focus: il reato e le emozioni connesse.
«Li abbiamo fatti sedere in cerchio – racconta Ilaria Marchetti, mediatrice – e abbiamo proposto giochi simbolici e interattivi per riflettere sul senso del danno che avevano causato. Non è facile: molti di loro si sentono vittime, e spesso lo sono. Ma in pochi incontri abbiamo visto cambiare lo sguardo. Hanno cominciato a pensare alle persone ferite dai loro comportamenti. A immaginarne i pensieri, la sofferenza».
Alla fine del percorso, sono emerse quattro parole chiave, scelte dagli stessi ragazzi: giustizia, inclusione, sostenibilità, riparazione. «Giustizia e inclusione – dice Marchetti – perché hanno bisogno di essere riconosciuti, non etichettati. Sostenibilità per la natura che li ha accolti. Riparazione per il desiderio di ricominciare».
La sfida di un nuovo modello
Il progetto, concluso dopo un anno di attività, non si chiude qui. Il desiderio, da parte dei promotori, è di capire come trasformare l’esperienza in un modello più ampio. «Non tutto è esportabile – ammette Tamanza – ma alcuni elementi sì: la collaborazione con il territorio, l’accompagnamento psicologico costante, l’integrazione tra formazione e giustizia minorile».
Anche per la magistratura minorile, il progetto rappresenta una possibile svolta. «La messa alla prova – conclude Tondina – è uno strumento prezioso, ma complesso. Richiede tempo, persone, risorse. Dobbiamo usarlo con intelligenza, sui casi che davvero ne possono trarre beneficio. Ma esperienze come questa ci dicono che ne vale la pena. Perché i ragazzi, se ben accompagnati, sanno trasformarsi».
Una comunità che accoglie
Nel frattempo, il progetto ha lasciato un segno nella città. Dopo la prima presentazione pubblica, diverse scuole, associazioni e gruppi informali si sono offerti di collaborare, anche con piccole donazioni. «Il segnale più bello – dice Tamanza – è stata la disponibilità di tanti cittadini a sentirsi parte di questo percorso. Non come spettatori, ma come alleati».
E in un tempo in cui la cronaca invoca spesso risposte punitive, questa piccola esperienza universitaria dice che una giustizia umana e trasformativa è possibile. Non facile, certo. Ma concreta, praticabile. Basta avere il coraggio di scommettere sulle risorse che i ragazzi, a volte, non sanno nemmeno di avere.