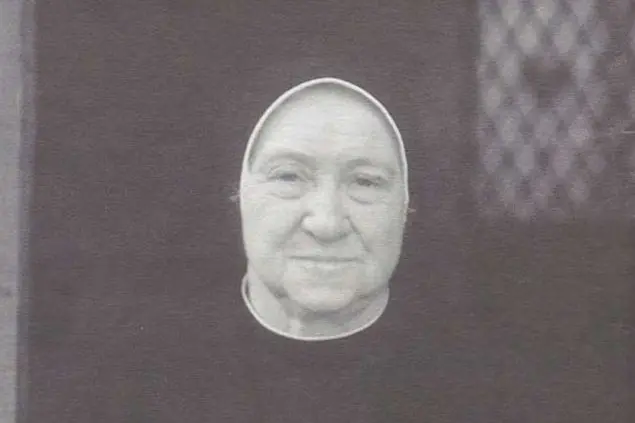PHOTO
“Ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Gesu’ non lascia margine a dubbi quando nel Vangelo indica la “retta via” che porta ad aiutare il popolo dei detenuti, al di là delle colpe commesse. E’ una strada lunga e complessa, difficile da percorrere. Tra i pochi a riuscirci, suor Gervasia Asioli, Orsolina delle Figlie di Maria Immacolata, al secolo Adele Asioli, nata a Desenzano sul Garda il 19 Maggio 1917 e scomparsa a Verona il 18 Luglio 2010. Una vita dedicata, tra gli istituti penitenziari di Verona e di Roma (Rebibbia), ad ergastolani, ex terroristi rossi e neri, ex brigatisti, condannati per assassinio e per delitti efferati. Ma anche a detenuti comuni, omosessuali, transessuali e prostitute con problemi di giustizia, ovvero quel popolo di dimenticati in attesa del “fine pena”, che hanno avuto in suor Gervasia una “amica sincera”, una “sorella maggiore”, quasi “una mamma” pronta ad aiutarli, in applicazione dell’evangelico ”ero in carcere…”. Nomi noti e meno noti che non passano inosservati come Francesca Mambro e suo marito Valerio “Giusva” Fioravanti, Gilberto Cavallini, Domenico Papalia, Vincenzo Andraus, Dario Mariani, Johnny Lo Zingaro, Alfredo Visconti “Fantomas”, accuditi dalla religiosa come “figli adottivi”.
Ne parlano, per la prima volta, Emanuele Roncalli (pronipote di S. Giovanni XXIII) e Gabriele Moroni nel libro fresco di stampa “Una suora all’Inferno” (Marietti editore, 140 pagine, euro 16,50). Una biografia resa ancora piu’ coinvolgente dalla pubblicazione di alcune lettere inedite intercorse tra i detenuti e la religiosa definita da Roncalli e Mori “figura storica del mondo del carcere che ha speso la sua intera vita negli istituti penitenziari”, libera dai rigidi vincoli canonici in vigore nei conventi e nei monasteri. Ma anche “una donna controcorrente, senza pregiudizi, spesso scomoda”, sempre pronta a difendere i diritti umani dei carcerati. “Abbiamo celle da 3 posti con dentro anche 9-10 detenuti. E’ disumano”, denuncia infatti suor Gervasia in una lettera alle autorità giudiziarie, spingendosi a dichiarare pubblicamente – sul modello di papi come San Giovanni Paolo II ed i suoi successori – a favore dell’umanizzazione delle pene e della redenzione dei detenuti. “Io sono per l’indulto. Altro che carcere! Ho conosciuto brigatisti, truffatori, ladri, assassini, pedofili, rapinatori e io assolvo tutti, buoni e cattivi. A giudicarli ci penserà Gesu’ nell’Aldilà”, ha infatti piu’ volte scritto e gridato la religiosa. Posizioni di certo urticanti per benpensanti e conservatori dentro e fuori la Chiesa, ma che suor Asioli ha sempre proclamato senza farsi intimidire. Un identikit politico-religioso confermato dalla deputata Simonetta Matone, magistrata di lungo corso, per anni Giudice di Sorveglianza del Tribunale di Roma, che nella Prefazione al libro – intitolata, non a caso, “Una suora rivoluzionaria” – scrive, tra l’altro, che “suor Gervasia era una figura mitologica, per il suo essere una religiosa fuori dagli schemi, rivoluzionaria fuori ogni convenzione…era politicamente scorretta, perseguiva un solo obiettivo: il bene dei detenuti”. “Non era in alcun modo interessata a chi fossero e a cosa avessero fatto”, sottolinea Matone, perchè “era interessata al loro presente, alle loro condizioni dietro le sbarre” e “riteneva che le carceri fossero un Inferno e che il suo obiettivo fosse alleviare quelle pene…”. Comunque, rivela ancora la magistrata ora deputata della Lega, “lei riteneva importante la preghiera, ma fino ad un certo punto, perché poi bisognava essere consapevoli con l’essere cristiani. Ed il suo essere cristiana militante era stare dalla parte dei detenuti e con i detenuti…”.
Naturale, quindi, che tra suor Gervasia ed i detenuti nascesse subito un feeling fatto di fiducia ed affetto reciproco, nei colloqui diretti e nelle lettere, “in una dimensione privata, intima, non senza debolezze e cedimenti, con continui rimandi – scrivono Emanuele Roncalli e Gabriele Moroni – agli anni di piombo, ai periodi piu’ bui della prima Repubblica, macchiata da attentati, sequestri di persona, omicidi”. In queste lettere, rilevano gli autori, “la strage di Bologna, il delitto Piersanti Mattarella, gli agguati a boss mafiosi, le rivolte nelle carceri, i piu’ grandi bluff milionari, emergono in filigrana, rievocati, dibattuti da coloro che non negano di essere stati dei ‘santi’, ma spesso negano di essere stati coinvolti in tali fatti…”. Come confida Valerio “Giusva” Fioravanti, condannato nel 1988 con la moglie Francesca Mambro per banda armata e per l’attentato alla Stazione di Bologna, in libertà condizionale dal 2004 e libero dal 2009. “Sono stanco – scrive Fioravanti il 9 Giugno 1988 - il processo si avvicina all’ora della sentenza e alla lunga anche io risento della tensione. In tanti anni questa è la prima volta che faccio un processo da innocente e mi ritrovo con le emozioni e le misure e le delusioni e le speranze di un qualsiasi carcerato. Speranzoso, ma non fiducioso!...Il libro di Santa Caterina l’ho letto io prima di passarlo a Francesca che ti ringrazia. Devo confessarti che ho fatto uno sforzo. La mia cultura è laica ed i toni di questi libri sono troppi agiografici…sono sicuro che il danno lo fanno gli scrittori perchè sicuramente i santi devono essere persone semplici e disponibili…”.
Altrettanto intenso il rapporto epistolare con Francesca Mambro, che in una lettera del 28 Gennaio 1989 lamenta, tra l’altro, di “non aver mai preso in giro nessuno e tantomeno la fiducia di chi mi ha dato comprensione, pazienza e attenzione. Non ho idea di cosa sta accadendo fuori e perché di questo ennesimo complotto ai nostri danni” da parte di chi “è interessato alla cristallizzazione dello stereotipo ‘mostri’, ‘killer’ di questo o di quell’altro…”. Lettere – secondo Roncalli e Moroni – dal tenore di sincera amicizia che non verrà mai meno anche dopo l’estinzione della pena della Mambro”, che confessa anche di aver avuto “un crollo psicologico dopo la sentenza di Luglio a Bologna”. Si tratta, puntualizzano gli autori, “dell’esito del processo di primo grado sulla strage di Bologna conclusosi con la sentenza dell’11 Luglio 1988, con ergastolo a lei e a Valerio Fioravanti, Massimiliano Fachini e Sergio Picciafuoco”. Contenuti religiosi, e colmi di riconoscenza, caratterizzano anche le lettere di Gilberto Cavallini, tra i fondatori dei Nar, condannato per terrorismo negli anni ’80, e per l’assassinio del Sostituto procuratore Mario Amato e la strage di Bologna. “Carissima suor Gervasia – scrive il 26 Marzo 1990 – nei nostri incontri e nelle nostre chiacchierate ho visto la vostra capacità di dedicarvi agli altri e di amare tutti indipendentemente dal colore politico, dalla razza, dal tipo di resto e via dicendo…ho potuto toccare con mano il sentimento piu’ apprezzato di nostro Signore, che cerco di non deludere anche se ovviamente sono ancora molto lontano dall’essere un esemplare seguace di Cristo…”. Parole e sentimenti presenti in tutte le altre lettere, come una sorta di ideale cordone ombelicale tra suor Gervasia ed i “suoi” detenuti, un filo di speranza sempre vivo che la religiosa “rivoluzionaria” non cesserà mai di tessere fino alla fine del suo tempo.