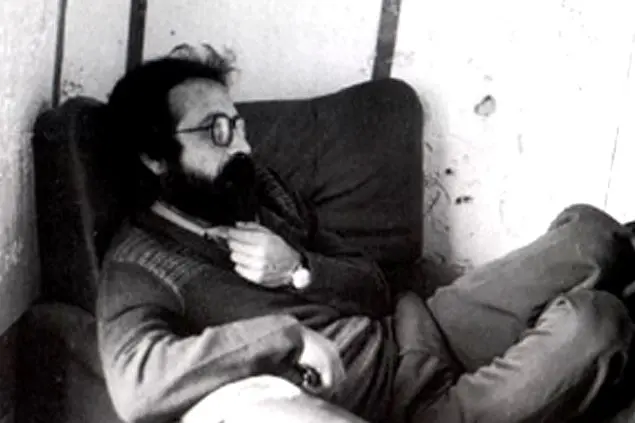PHOTO
Nella notte del 9 maggio del 1978, a Cinisi, in provincia di Palermo, fu assassinato Peppino Impastato, poeta, scrittore, giornalista, fondatore di Radio Aut e militante della sinistra antagonista. Al fianco di familiari e compagni, sin dall’inizio si schierò il Centro di documentazione Giuseppe Impastato, fondato dal sociologo Umberto Santino e da sua moglie, la docente Anna Puglisi.
Professore Santino, quando conobbe Peppino Impastato?
«Contrariamente a quello che si pensa, con Peppino io non ero né amico né compagno di militanza. Abitualmente si crede che per fare antimafia, soprattutto quando si fa riferimento a un personaggio, bisogna che ci sia un rapporto di parentela o di appartenenza. Con Peppino da vivo non ho avuto rapporti, per ragioni di età (Anna Puglisi ed io avevamo nove anni in più di lui), ma soprattutto per ragioni politiche: militavamo in formazioni diverse e, in omaggio a una tradizione, che ha sempre o quasi sempre segnato le sinistre, tra i vari gruppi non c’era collaborazione, ma concorrenza e distacco. Ho conosciuto bene Peppino quando non c’era più e ho capito che aveva lasciato un patrimonio che non poteva essere disperso».
Cosa ricorda delle giornate successive al delitto?
«Con Anna corsi a Cinisi subito dopo avere avuto la notizia. Trovammo una situazione angosciante. Già si era sparsa la voce che era morto facendo un attentato o si era suicidato. Ma un piccolo manifesto recitava: “È stata la mafia”. Come Centro di documentazione, che era già nato un anno prima, firmammo un esposto i cui scrivemmo che era stato un omicidio. Al funerale, il 10 maggio del ’78, eravamo in tanti, ma compagni che mi conoscevano mi dissero che di Cinisi e Terrasini, paesi contigui, c’erano pochissime persone. Venivamo quasi tutti da Palermo e dai paesi vicini. La mattina dell’11 maggio partecipammo a un’assemblea all’Università, con il professore di Medicina legale in pensione Ideale Del Carpio, una bella figura di scienziato e di militante, per dimostrare (si era trovato il frammento di una mano) che l’esplosivo non era tra le mani di Peppino ma era stato posto sotto il torace. Di pomeriggio sarebbe dovuto esserci il comizio di chiusura della campagna elettorale di Democrazia Proletaria, assegnato a Peppino insieme a un dirigente milanese, Franco Calamida».
Come mai la scelta del sostituto di Peppino ricadde proprio su Umberto Santino, non essendo un suo amico?
«Maria Cuomo, anch’essa milanese ma trasferitasi in Sicilia per dare una mano ad Avanguardia operaia mi disse che i compagni di Peppino non se la sentivano di fare il comizio e mi chiese se potevo farlo io. Sapeva che mi ero occupato di mafia e per un anno avevo militato in quel gruppo. Risposi affermativamente e chiesi a qualcuno dei compagni di Peppino se avessero un’idea precisa delle responsabilità. Mi dissero che i mafiosi di Cinisi era noti e notissimo il loro capo: Gaetano Badalamenti. Pronunciai il suo nome alla fine del comizio. Ma non vi furono né immagini né registrazioni. Intanto il binario era stato riparato, tracce importanti erano state cancellate e furono alcuni compagni che, rovistando all’interno di un casolare abbandonato, scoprirono tracce di sangue. Erano di Peppino. Era stato tramortito o ucciso nel casolare e poi fatto esplodere sui binari. Ma già la sentenza era stata pronunciata, prima dell’inchiesta e del processo. Il procuratore Gaetano Martorana, in un fonogramma dettato la stessa mattina della scoperta dei resti di Peppino, aveva scritto: “attentato alla sicurezza dei trasporti operato da tale Impastato Giuseppe che... sul binario della linea Trapani-Palermo aveva collocato un ordigno della cui esplosione era rimasto vittima”. A sostenere la tesi dell’omicidio mafioso eravamo in pochi e isolati. E i compagni di Peppino erano gli amici, o forse i complici, del terrorista».
Peppino fu sostenuto sia dalla madre Felicia Bartolotta sia dal fratello Giovanni, che poi ebbero un ruolo importante nella difesa della sua memoria e nella lotta per la verità e per la giustizia…
«La madre e il fratello presentarono un loro esposto in cui evidenziavano le campagne di denuncia di Peppino contro i Badalamenti e altri presunti mafiosi. Il 16 maggio 1978 si presentarono a Palazzo di giustizia e la madre disse: “non voglio vendetta ma giustizia”. Una rottura netta, storica, con la parentela mafiosa. La intervistò Mario Francese, un grande giornalista ucciso nel gennaio del 1979, e le chiese di suo cognato. Il cognato era Cesare Manzella, il capomafia ucciso in un attentato con un’autobomba nell’aprile del 1963. Così appresi che Peppino era figlio di un mafioso e nipote di un capomafia. Un caso unico nella storia delle lotte antimafia, che Peppino aveva avviato a partire dalla sua famiglia. Fu una scoperta che cambiò la vita mia e di Anna. Dovevamo fare del nostro meglio per salvare la memoria di Peppino e fare emergere la verità».
Quali furono i principali interventi del Centro di documentazione da Lei fondato per ottenere giustizia nel caso Impastato?
«Abbiamo svolto un’attività che non ha avuto soste, prima accanto ad alcuni compagni di Peppino, poi con la madre e il fratello. Sapevamo che era una battaglia difficile, se non impossibile. Con il bollettino del Centro 10 anni di lotta contro la mafia, pubblicato due mesi dopo il delitto, abbiamo documentato l’attività di Peppino e avviato una riflessione sulla mafia, a partire dal concetto di borghesia mafiosa. Abbiamo tempestato il palazzo di Giustizia, trovando per fortuna un appoggio al suo interno: Rocco Chinnici, consigliere istruttore, che era convinto che si trattava di un omicidio mafioso. Nel maggio del ’79 abbiamo pubblicato il bollettino Accumulazione e cultura mafiose e organizzato la prima manifestazione nazionale contro la mafia… Gli unici quotidiani che ci sostenevano era “Lotta continua” e “Il Quotidiano dei lavoratori”, che si apprestavano a chiudere. Alla manifestazione parteciparono circa duemila persone e c’era uno schieramento di forze dell’ordine che dovevano tenere a bada i “compagni del terrorista”».
Tra i magistrati che respinsero il depistaggio spiccarono illustri vittime della mafia (come il consigliere istruttore Rocco Chinnici, il procuratore Gaetano Costa e lo stesso Giovanni Falcone), ma anche il capo del Pool Antimafia di Palermo Nino Caponnetto e i giudici dell’ultimo processo (come la PM Franca Imbergamo e la Corte d’Assise presieduta da Claudio Dall’Acqua).
«Nel 1984 ci fu un’ordinanza-sentenza preparata da Chinnici, assassinato nel luglio del 1983, e completata dal successore Antonino Caponnetto, in cui si riconosceva che si era trattato di un omicidio mafioso, ma ad opera di ignoti. Pubblicammo un dossier dal titolo Notissimi ignoti con il volto di Badalamenti in copertina e presentammo altri esposti per la riapertura delle indagini. Si giunse a Badalamenti con la pubblicazione del libro La mafia in casa mia, in cui la madre di Peppino parlava di suo marito, che era andato in America dopo un incontro con Badalamenti (Peppino aveva diffuso un volantino in cui lo definiva “esperto di lupara ed eroina”) e a una sua nipote, parlando di quell’incontro, aveva annunciato: “Io gliel’ho detto: prima di uccidere Peppino dovete uccidere me”. Al palazzo di giustizia, dopo l’assassinio di Chinnici, c’erano altri magistrati che continuavano il suo lavoro, Caponnetto, Caselli, Imbergamo (futuro Pubblico ministero nei processi a Badalamenti e al suo vice, Vito Palazzolo). Falcone, con il libro in mano, andò negli Stati Uniti per interrogare Badalamenti, in carcere per la condanna nel processo alla Pizza Connection per traffico di droga. Ma Badalamenti si limitò a dire che con gli Impastato erano amici e che Luigi, il padre di Peppino, gli aveva detto che era preoccupato per suo figlio, per la sua attività politica, ma lui l’aveva rassicurato: con la gioventù di oggi poteva andare peggio. Il riferimento era probabilmente alla droga…».
Quali furono le ragioni dell’omicidio e del successivo depistaggio?
«Le ragioni vanno ricercate nelle denunce continue e documentate delle attività della mafia e dei suoi complici, ma pure nell’irrisione, con la trasmissione satirica “Onda pazza” di Radio Aut, considerata una forma di lesa maestà… Il depistaggio derivava dalla convinzione che, trattandosi di un “estremista”, poteva essere diventato un terrorista, seguendo altri militanti dei gruppi “rivoluzionari” che avevano imboccato quella strada, ma Peppino considerava il terrorismo una negazione della lotta di classe. E poi la stessa mattina del 9 maggio a Roma fu trovato il corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate rosse. Il clima era quello: la caccia ai terroristi rossi, mentre con i fascisti si seguiva un percorso diverso, perché delitti e stragi neofascisti erano progettati e organizzati con la complicità di soggetti istituzionali, come i servizi segreti. Riuscimmo ad ottenere le condanne di Badalamenti e di Vito Palazzolo, ma il depistaggio rimase fuori dalla vicenda giudiziaria e chiedemmo di occuparsene alla Commissione parlamentare antimafia. La richiesta fu accolta, si costituì un Comitato presieduto da Giovanni Russo Spena (esponente di Rifondazione Comunista, ndr), e nel dicembre del 2000 fu approvata una relazione secondo cui rappresentanti della magistratura e delle forze dell’ordine avevano depistato le indagini e avevano coperto i mafiosi. Finora un fatto unico nella storia dell’Italia repubblicana…. Penso che anche per la trattativa Stato-mafia, dopo il verdetto della Cassazione, la parola dovrebbe passare a una Commissione parlamentare».
Il concetto di borghesia mafiosa, richiamato dal Procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia nella storica conferenza stampa dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro, fu introdotto negli anni Settanta da Umberto Santino nella sociologia e dall’economista Mario Mineo nella politica. Mezzo secolo dopo, nell’era dell’inabissamento, la borghesia mafiosa è più forte? E in cosa consiste precisamente?
«Il mio concetto di borghesia mafiosa non nacque da zero. Riprese le riflessioni di Leopoldo Franchetti (parlamentare liberale di fine Ottocento, ndr) che, nella sua inchiesta privata del 1876, condotta assieme a Sidney Sonnino (altro parlamentare liberale di Fine Ottocento, ndr), parlava di “facinorosi della classe media”, che si arricchivano e acquisivano posizioni di potere attraverso “l’industria della violenza” e avevano un rapporto privilegiato con le istituzioni. Nei primi anni Settanta, Mario Mineo parlava di “borghesia capitalistico-mafiosa” con un ruolo egemonico nell’amministrazione regionale. Nei miei studi ho collocato i soggetti della borghesia mafiosa (professionisti, imprenditori, amministratori, rappresentanti della politica e delle istituzioni) all’interno dell’associazione mafiosa (ci sono stati medici capimafia come Michele Navarra) e nel sistema relazionale, che costituisce gran parte della forza della mafia, consentendole una serie di attività che i mafiosi, con capacità inadeguate, non potrebbero neppure immaginare, e assicurando le coperture necessarie per ottenere l’impunità. Con l’arresto di Messina Denaro si è “scoperta” la borghesia mafiosa, dopo la constatazione che senza la complicità di medici, amministratori, imprenditori, la sua latitanza non sarebbe durata trent’anni».
Oggi siamo in presenza di una mafia sempre più affarista e imprenditrice…
Oggi si parla di una mafia che ha rinunciato alla violenza perché i grandi delitti e le stragi hanno avuto un effetto boomerang, per i mafiosi, ma non per gli eventuali complici all’interno delle istituzioni, e di una mafia elitaria, mercatista, quella che già negli anni ‘80, con il mio saggio sulla “mafia finanziaria”, chiamavo “holding mafiosa”, che opera in un quadro che il sociologo Luciano Gallino definiva “Finanzcapitalismo”. La mafia affianca le evoluzioni della società capitalistica e ne fa parte, con un sistema finanziario che rende difficile operare la distinzione tra capitali legali e illegali»