PHOTO
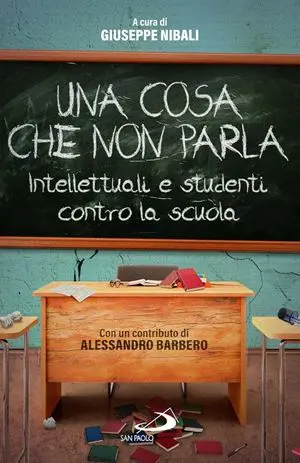
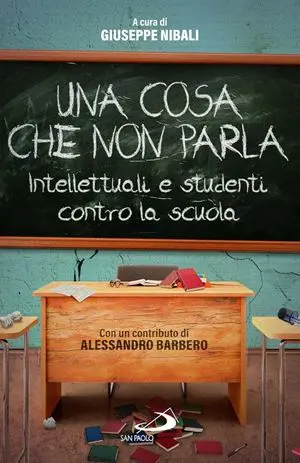
Ancora pochi giorni di attesa e le campanelle delle scuole di tutta Italia riprenderanno a suonare. Il ritorno o la prima volta in classe rappresenterà per milioni di studenti l’inizio di un’avventura di vita, tra istruzione, conoscenze e momenti sia belli che difficili ma sempre di enorme crescita personale. Parallelamente, però, l’avvio del nuovo anno scolastico porta con sé alcuni pesanti dubbi, legati al rapporto sempre più complesso e conflittuale che molti giovani, soprattutto adolescenti, hanno con la scuola. Un luogo dove il dialogo in molti casi non riesce a essere più centrale e l’insegnamento si fa troppo tecnico e poco umano. Giuseppe Nibali, docente e scrittore classe 1991, ha recentemente pubblicato in merito l’opera (edita da San Paolo Editori) Una cosa che non parla. Intellettuali e studenti contro la scuola. E ora analizza i vari elementi di contrasto, sottolineati anche dai ragazzi protagonisti stessi del libro.
Professor Nibali, da quale sua esigenza nasce l’idea di quest’opera?
«La cosa che mi interessava di più era appunto parlare di scuola, perché è uno di quei settori che io vivo e visito da ormai molto tempo. Un luogo a mio avviso privato, che riguarda me e i ragazzi. Un luogo poi particolare, che per me era fonte di divertimento e distrazione, oggi visto da molti studenti e docenti come un posto di dolore e depressione».
Come mai, per lei, il dolore è un elemento ormai dilagante nelle scuole?
«I ragazzi non si sentono compresi, cercano una relazione e delle conoscenze che spesso non trovano. Poi il discorso è sempre soggettivo, c’è chi a scuola si ambienta benissimo. Però in generale questo dolore è una questione esistenziale e strutturale. La scuola italiana costringe i suoi giovani, nel pieno della loro potenza fisica e intellettuale, a stare seduti su una sedia per 6/8 ore al giorno. C’è una mortificazione del corpo e un accanimento sul concetto della disciplina mentale. Gli insegnanti, invece, dovrebbero puntare più sul stimolare la passione e la curiosità. Certo pure molti docenti hanno problemi che derivano dal sistema scolastico. Diventa tutto un circolo vizioso che fa vedere spesso la scuola come una galera».
Nel libro i ragazzi dialogano con alcuni accademici. Come intende lei il concetto di dialogo, elemento sempre più centrale e richiesto dagli studenti?
«Per me esistono due tipi di dialogo. Quello simmetrico, dove il docente si mette al pari dello studente. Modalità interessante, ma che comporta dei rischi. Io sono più per il dialogo asimmetrico, dove ragazzi e insegnanti devono considerarsi assolutamente uguali dal punto di vista umano ma non su quello della conoscenza. Attenzione, non vuol dire che gli studenti non possono insegnare nulla ai professori. Io imparo moltissimo da loro. Però a livello di conoscenze intellettuali noi possiamo dare di più ai ragazzi. Il dialogo deve partire da qui, i docenti devono essere stimati per le loro conoscenze intellettuali e per come le trasmettono. Nel mio libro il dialogo tra studenti e accademici si basa sul rispetto reciproco, ma soprattutto sull’esperienza che questi insegnanti hanno e mettono a disposizione. I ragazzi hanno bisogno di trovare punti di riferimento chiari».
I giovani d’oggi vengono spesso accusati di non essere interessati a nulla, mentre loro rispondono di avere molti ideali ma di non potersi esprimere al meglio. Dove sta la verità?
«Questo è un ragionamento generazionale. Cioè che ogni generazione pensa di essere migliore di quella successiva. Il passato poi viene considerato sempre migliore. Pure Cicerone e Leopardi pensavano che la loro epoca fosse meno interessante di quella passata. I ragazzi di oggi vengono visti come irrispettosi, ma assicuro che non è così. Io noto invece grandi potenzialità in loro e la scuola deve aiutarli a svilupparle. Certo poi ci sono i geni e quelli meno bravi, ma sono tutti in gamba».
Cosa pensa delle nuove e più stringenti norme ministeriali più stringenti, legate al divieto di utilizzo dei cellulari nelle scuole?
«Si tratta di un’operazione di previdenza tanto voluta dal Ministro Valditara, che io non condivido. Innanzitutto bisognerebbe togliere i telefoni anche ai docenti. Spesso vedo in alcune classi che il docente assegna lavori di gruppo e poi si mette con la testa bassa a guardare il telefono. Per me i cellulari sono anche utili per alcuni aspetti delle lezioni. Con questo divieto si vuole portare ancora di più i ragazzi in una scuola da “anni 80”. Una scuola rimasta ancorata nel passato, piena di burocrazia e divieti. Con intervalli e campanelle che richiamano carceri e fabbriche. I ragazzi continueranno a usare i telefoni, perché spesso troveranno insegnanti meno zelanti nel controllo. In caso contrario escogiteranno altri metodi per distrarsi».
Concludendo con un altro tema del suo libro: i ragazzi sostengono di essere considerati solo un numero o un voto. Che idea si è fatto di quegli studenti che hanno rifiutato di fare l’esame orale alla maturità per protesta?
«Penso innanzitutto che sarà poco divertente vedere cosa succederà l’anno prossimo. Chi sosterrà l’orale anche se farà scena muta perché non ha studiato magari verrà promosso se raggiunge il punteggio minimo. Chi non lo farà per scelta consapevole verrà bocciato a prescindere dal voto. E questo per me è un sistema punitivo. Noi dobbiamo formare i ragazzi come futuri cittadini e rendere il loro pensiero critico, totalmente autonomo. Senza basare tutto su un voto. Il numero ormai crea ansia nei ragazzi. Un’ansia ingigantita dalle aspettative familiari, dai giudizi dei social e dalle dinamiche di una società troppo competitiva. Poi certo, anche se comprendo la scelta di questi studenti, a me spiace che si rinunci a fare l’orale, è la cosa più bella della maturità perché puoi esprimerti al meglio».




