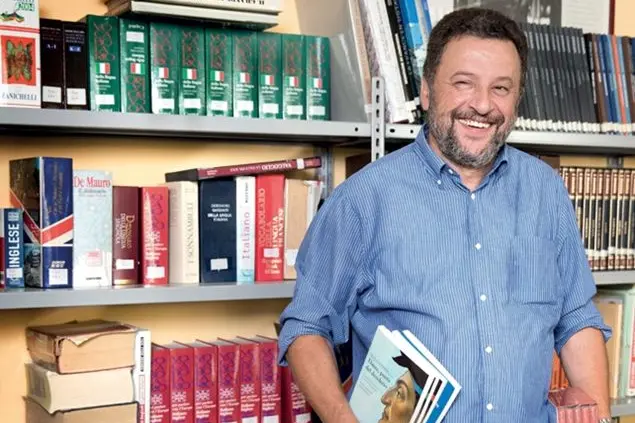PHOTO
«Intitolare la Divina Commedia il poema della misericordia non sarebbe affatto una forzatura. Dante nel suo viaggio dall’inferno al paradiso ci mostra e ci racconta come Cristo lo ha abbracciato e salvato facendogli seguire semplicemente ciò che amava, che nel suo caso erano Beatrice e Virgilio. E io, nel mio piccolo, cerco di condurre le persone che incontro — i giovani soprattutto, ma non solo — a entrare in questo dialogo con Dante, che scrive per dare a ogni lettore la possibilità di vedere il bene di ogni cosa, di uscire dal sepolcro e di riscoprire la dignità dell’uomo che si fida di Dio e sente la vita come una grande promessa». Franco Nembrini, bergamasco, professore di liceo, quarto di dieci figli e padre di quattro, da quando aveva 11 anni dialoga con Dante: «Sono rimasto folgorato, una estate, dopo la prima media, quando per aiutare la mia famiglia sono andato a fare il garzone in un negozio di alimentari a Bergamo, lontano da casa. Una notte, stanco e affaticato come solo un bambino può sentirsi, mentre scaricavo delle casse mi risuonò in mente la terzina del diciassettesimo canto del Paradiso in cui Dante descrive l’esilio: “Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui e come è duro calle lo scendere e ’l salir per l’altrui scale”. E mi sono sentito capito da un uomo di 700 anni prima. Da allora il dialogo non si è mai interrotto».
Oggi Nembrini gira l’Italia, e non solo, con El Dante, lo legge, lo spiega, lo racconta. Ha incantato anche Roberto Benigni, che si è ispirato ad alcuni suoi libri di commento. E dal prossimo 8 dicembre, in occasione del Giubileo della misericordia, sarà sugli schermi di Tv2000 per 34 puntate, tutti i lunedì sera alle 21. Con Dante, ovviamente.
Professore, lei dice del suo amato Dante che è poeta del desiderio e della misericordia. In che senso?
«Dante e il suo viaggio sono l’inizio di un desiderio. Dio ci parla attraverso le cose che amiamo. E per Dante sono le donne, Beatrice in particolare, e poi Virgilio, la letteratura. La vita non conosce scorciatoie, dice il primo canto: c’è da scendere nelle profondità del cuore, stando alle circostanze in cui Dio ci mette, per vedere il male, l’inferno, e tentare di purificarsi lasciandosi abbracciare dal perdono di Dio. Si arriva per questa strada finalmente al bene, fino a sperimentare il paradiso anche su questa terra. Beatrice è per Dante il modo in cui Cristo lo ha abbracciato e salvato e il poeta viene a raccontarcelo per invitarci al viaggio, ognuno al suo. L’uomo è una domanda, ha il desiderio di essere perdonato, e Dio è la risposta, con la sua misericordia. La scoperta che fa Dante è che il suo desiderio, apparentemente negato con la morte di Beatrice, non rimane inascoltato. La prima parola che dice a Virgilio è “Miserere”. E come diceva don Giussani, mio maestro: “Il vero protagonista della storia è il mendicante. L’uomo è mendicante e c’è Cristo che accoglie”».
Dove nasce il suo rapporto con la fede?
«Nasco in una famiglia molto cattolica. Mio padre ci aspettava tutte le sere quando rientravamo a casa per recitare, con ognuno di noi dieci fratelli, la Compieta insieme. Mia madre sognava di avere un figlio prete. Per un po’ di tempo questa struttura familiare mi ha tenuto vicino alla Chiesa. Ma ho vissuto in pieno ’68 e a un certo punto qualcosa non ha retto e sono entrato in crisi. Tra due generazioni di padri e figli si era infilata la modernità e a mio padre era mancato il metodo per annullare quella distanza. Avevo una sorella legata a Comunione e liberazione e le chiedevo polemicamente: “Ma da cosa ti avrebbe salvato questo Salvatore e soprattutto, come?”. Poi un giorno don Giussani è entrato in casa nostra, ed è cambiato tutto. Da allora sono tornato alla fede e alla Chiesa con rinnovato vigore».
Cosa ha fatto don Giussani per riportarla alla fede?
«Un gesto che ancora ricordo bene. Un giorno venne a casa nostra perché una delle mie sorelle voleva entrare in monastero di clausura (oggi ha quattro figli). Mia madre si confessò con lui in quell’occasione e probabilmente gli disse le sue pene per uno dei nostri fratelli, Angelo, che era uscito dal seminario ed era diventato membro di un gruppo dell’estrema sinistra e nemico della Chiesa. Angelo quel giorno non era in casa. Dopo pochi giorni arrivò a casa nostra un pacco di libri mandati da don Giussani. Erano per Angelo e io pensai: “Ecco, gli avrà mandato la solita Bibbia o altri testi per riconvertirlo”. E invece quando Angelo tornò ed apri il cartone c’erano tutti titoli tipo Il Capitale di Marx: insomma, testi contro la Chiesa. Gli aveva mandato i libri che sarebbero piaciuti a lui. Lì ho capito che questa era una cosa di Dio e ho cominciato a seguire gli incontri di Cl. Lui non voleva cambiarlo, gli dava la vita senza chiedergli altro. Mio fratello non è più tornato a essere cristiano, ma quel giorno mi è entrata dentro questa idea della misericordia che non mi ha più lasciato: l’educazione come misericordia».
È questa la sua missione oggi? Educare con misericordia?
«Alla prima lezione che tenevo in ogni nuova classe (Nembrini ha smesso di insegnare da poco, per motivi di salute, ndr) citavo Machiavelli: “Io vi sfido, vi accompagno nelle coorti degli antiqui uomini, dei poeti, dei grandi, perché per vivere, ci vuole il coraggio di essere vivi, consapevoli della propria dignità e con il cuore in mano avere coscienza della propria grandezza”. Ecco, io porto chi mi segue da Dante, lo accompagno dentro questo grande poema della misericordia, e a lui tutti possono consegnare le proprie attese e domande. Iniziare qualcuno a una possibilità di dialogo con l’infinito, che può durare tutta la vita, mi sembra un buon servizio al prossimo. Perché tutto risponde: la letteratura, l’arte, il cielo, le nuvole, la bellezza del creato… Ma ci vuole un mezzo per cominciare».
Oggi Nembrini gira l’Italia, e non solo, con El Dante, lo legge, lo spiega, lo racconta. Ha incantato anche Roberto Benigni, che si è ispirato ad alcuni suoi libri di commento. E dal prossimo 8 dicembre, in occasione del Giubileo della misericordia, sarà sugli schermi di Tv2000 per 34 puntate, tutti i lunedì sera alle 21. Con Dante, ovviamente.
Professore, lei dice del suo amato Dante che è poeta del desiderio e della misericordia. In che senso?
«Dante e il suo viaggio sono l’inizio di un desiderio. Dio ci parla attraverso le cose che amiamo. E per Dante sono le donne, Beatrice in particolare, e poi Virgilio, la letteratura. La vita non conosce scorciatoie, dice il primo canto: c’è da scendere nelle profondità del cuore, stando alle circostanze in cui Dio ci mette, per vedere il male, l’inferno, e tentare di purificarsi lasciandosi abbracciare dal perdono di Dio. Si arriva per questa strada finalmente al bene, fino a sperimentare il paradiso anche su questa terra. Beatrice è per Dante il modo in cui Cristo lo ha abbracciato e salvato e il poeta viene a raccontarcelo per invitarci al viaggio, ognuno al suo. L’uomo è una domanda, ha il desiderio di essere perdonato, e Dio è la risposta, con la sua misericordia. La scoperta che fa Dante è che il suo desiderio, apparentemente negato con la morte di Beatrice, non rimane inascoltato. La prima parola che dice a Virgilio è “Miserere”. E come diceva don Giussani, mio maestro: “Il vero protagonista della storia è il mendicante. L’uomo è mendicante e c’è Cristo che accoglie”».
Dove nasce il suo rapporto con la fede?
«Nasco in una famiglia molto cattolica. Mio padre ci aspettava tutte le sere quando rientravamo a casa per recitare, con ognuno di noi dieci fratelli, la Compieta insieme. Mia madre sognava di avere un figlio prete. Per un po’ di tempo questa struttura familiare mi ha tenuto vicino alla Chiesa. Ma ho vissuto in pieno ’68 e a un certo punto qualcosa non ha retto e sono entrato in crisi. Tra due generazioni di padri e figli si era infilata la modernità e a mio padre era mancato il metodo per annullare quella distanza. Avevo una sorella legata a Comunione e liberazione e le chiedevo polemicamente: “Ma da cosa ti avrebbe salvato questo Salvatore e soprattutto, come?”. Poi un giorno don Giussani è entrato in casa nostra, ed è cambiato tutto. Da allora sono tornato alla fede e alla Chiesa con rinnovato vigore».
Cosa ha fatto don Giussani per riportarla alla fede?
«Un gesto che ancora ricordo bene. Un giorno venne a casa nostra perché una delle mie sorelle voleva entrare in monastero di clausura (oggi ha quattro figli). Mia madre si confessò con lui in quell’occasione e probabilmente gli disse le sue pene per uno dei nostri fratelli, Angelo, che era uscito dal seminario ed era diventato membro di un gruppo dell’estrema sinistra e nemico della Chiesa. Angelo quel giorno non era in casa. Dopo pochi giorni arrivò a casa nostra un pacco di libri mandati da don Giussani. Erano per Angelo e io pensai: “Ecco, gli avrà mandato la solita Bibbia o altri testi per riconvertirlo”. E invece quando Angelo tornò ed apri il cartone c’erano tutti titoli tipo Il Capitale di Marx: insomma, testi contro la Chiesa. Gli aveva mandato i libri che sarebbero piaciuti a lui. Lì ho capito che questa era una cosa di Dio e ho cominciato a seguire gli incontri di Cl. Lui non voleva cambiarlo, gli dava la vita senza chiedergli altro. Mio fratello non è più tornato a essere cristiano, ma quel giorno mi è entrata dentro questa idea della misericordia che non mi ha più lasciato: l’educazione come misericordia».
È questa la sua missione oggi? Educare con misericordia?
«Alla prima lezione che tenevo in ogni nuova classe (Nembrini ha smesso di insegnare da poco, per motivi di salute, ndr) citavo Machiavelli: “Io vi sfido, vi accompagno nelle coorti degli antiqui uomini, dei poeti, dei grandi, perché per vivere, ci vuole il coraggio di essere vivi, consapevoli della propria dignità e con il cuore in mano avere coscienza della propria grandezza”. Ecco, io porto chi mi segue da Dante, lo accompagno dentro questo grande poema della misericordia, e a lui tutti possono consegnare le proprie attese e domande. Iniziare qualcuno a una possibilità di dialogo con l’infinito, che può durare tutta la vita, mi sembra un buon servizio al prossimo. Perché tutto risponde: la letteratura, l’arte, il cielo, le nuvole, la bellezza del creato… Ma ci vuole un mezzo per cominciare».