PHOTO
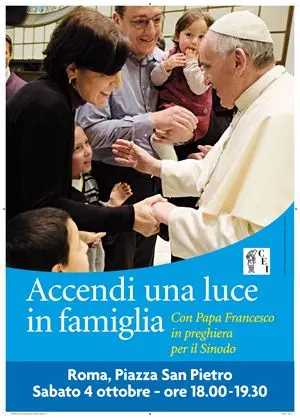
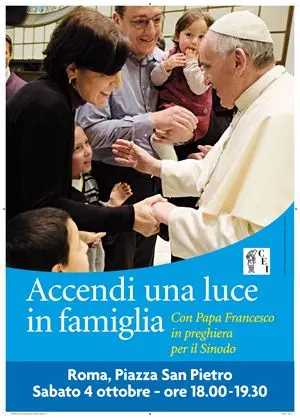
Il cardinale Péter Erdő, arcivescovo di Budapest, è stato scelto dal Papa come relatore al Sinodo dei vescovi sulla famiglia. E’ anche presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa. Di carattere schivo non ama parlare con la stampa e le sue interviste sono davvero poche. Ma alla vigilia del Sinodo ha accettato di fare il punto sulle questioni che da lunedì 6 ottobre saranno sul tavolo del Sinodo.
Eminenza, come giudica il dibattito, a volte anche polemico, che vi è stato tra i cardinali? «Inviterei a non enfatizzare. Non c’è stato un dibattito globale nella Chiesa sulla questione della Comunione ai divorziati risposati. E’ un problema che riguarda minoranze in alcune Chiese e in alcuni Paesi. Nel merito ritengo che in genere il confronto, anche quello tra le idee dei cardinali, sia positivo e lo è stato anche in questo caso».
Potrebbe essere stato un tentativo di bloccare la discussione al Sinodo prima che iniziasse?
«Non mi pare. Che ci siano su questo tema posizioni differenti nella Chiesa e tra i teologi e i canonisti è noto. E’ solo accaduto che in vista del Sinodo quel dibattito, che data decine d’anni, è riemerso».


Però per ben due volte è intervenuto contro le tesi del cardinale Kasper addirittura il prefetto della Congregazione della dottrina della fede il cardinale Gerhard Mueller...
«Certo capisco l’interesse, ma voglio sottolineare che anche durante il Concilio c’erano discussioni su molti punti anche di carattere dottrinale con la partecipazione dei più grandi teologi dell’epoca e con argomenti di forte spessore. E la Chiesa non ne ha sofferto».
Dunque nessuna chiusura sull’argomento?
«Assolutamente no. E’ uno dei temi del Sinodo, anche se non forse quello principale. Ed è uno dei problemi messi in risultato dai questionari inviati dalla Segreteria del Sinodo in vista della preparazione. Sicuramente se ne parlerà. Ma è anche un argomento che va visto nel contesto generale della crisi del matrimonio».
In che senso?
«Il problema principale è che la gente non si sposa più, che cedono in diversi parti del mondo anche i matrimoni civili. Questo è il problema che io chiamo fuga dalle istituzioni, paura di costruire il futuro della società. La questione della Comunione è marginale».
Però si tratta di persone che chiedono in questo modo di essere riammessi a pieno titolo nella Chiesa, pur sapendo di aver sbagliato, e di essere perdonati per poter accedere al sacramento. Come si può coniugare dottrina e misericordia?
«Intanto è bene sottolineare che i membri di quelle che chiamiamo famiglie ferite hanno posto nella Chiesa, devono essere accolti e devono sentirsi bene a casa, malgrado i loro problemi. Per il resto ci sono molte proposte, che non devono cambiare la dottrina, ma che devono adattare la pastorale. Tenendo conto che in alcune Chiese locali il problema non si pone affatto, in altre è relativo e solo in poche è davvero una questione principale, credo che si debba cercare una soluzione con generosità tenendo conto dei singoli casi. Dai due Sinodi sulla famiglia, quello di quest’ anno e quello dell’anno prossimo usciranno certamente delle proposte e poi sarà il Papa a prendere eventuali decisioni».


Dal suo osservatorio di presidente dei vescovi europei come è la situazione in Europa?
«Le indagini sociologiche dicono che la maggior parte degli europei aspira ad un rapporto duraturo. La famiglia sta in alto nella scala dei valori secondo una ricerca dell’ European values study, e viene considerata il luogo privilegiato di educazione dei figli. Eppure il matrimonio tradizionale perde terreno e aumentano le convivenze. Io leggo tutto ciò come una fuga dalle istituzioni. C’è l’allontanamento dalla politica e più in generale un desiderio di non impegnarsi nelle istituzioni. Vale anche per l’istituzione del matrimonio. Dobbiamo cercare le parole giuste per spiegare che il matrimonio è importante, ma non lo devono fare solo i vescovi, i preti e i cattolici. Un calo nei matrimoni deve preoccupare la società intera e anche la politica».
E come si può rimediare?
«Puntando sulla solidarietà, ripensando ai rapporti tra vicini, cercando di far fare alle famiglie amicizia con altre famiglie, aiutandosi a vicenda. Insieme si può leggere la Bibbia, ma anche fare la spesa. Ci sono esperienze nelle Chiese europee che possono diventare un esempio».
Si è lasciato passare troppo tempo, ben 33 anni, dalla Familiaris Consortio di Giovanni Paolo II?
«Quel resto resta fondamentale, ma non è vero che la Chiesa in questi anni non ha fatto nulla e ora improvvisamente con due Sinodi scopre i problemi della famiglia. Ci sono stati incontri, anche mondiali, libri, ricerche, approfondimenti scientifici dei problemi della famiglia da tutti i punti di vista. La Chiesa in questi anni non ha dimenticato la famiglia. E non è neppure vero che si è mantenuto il punto fermo sulla dottrina dimenticando la pastorale. Sono nate e cresciute molte associazioni e comunità che lavorano per la famiglia e hanno proposto buone analisi e ottimi metodo di intervento. Forse non le abbiamo messe abbastanza al centro delle nostre prassi pastorali».
Secondo lei i problemi principali della sofferenza delle famiglie quali sono?
«Il lavoro e quindi l’aumento della povertà che mette in crisi la famiglia e le migrazioni e non solo quelle degli africani che sbarcano in Europa. Ci sono migrazioni interne in Europa spaventose e nessuno se ne occupa. Oggi è la precarietà sociale ed economica il peggior nemico della famiglia».




