PHOTO
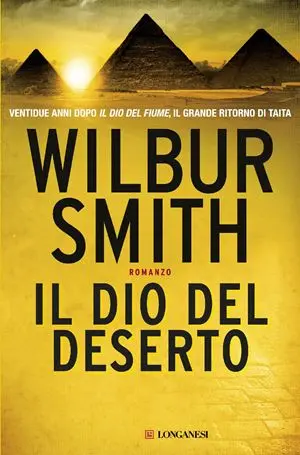
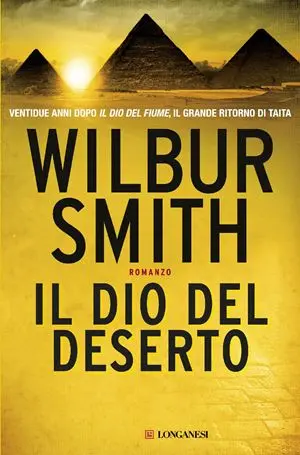
Alcune anticipazioni del nuovo libro di Wilbur Smith, il dio del deserto (Longanesi).
Uno dei papiri più noti della collezione del Museo Egizio di Torino è il resoconto di un processo svoltosi all’epoca del faraone Ramesse III (1183-1152 a.C.). Il re nomina un tribunale di dodici funzionari per giudicare una serie di individui, in gran parte cortigiani, funzionari e donne del cosiddetto "harem" (la sezione del palazzo dove alloggiavano le mogli del re), colpevoli di aver cospirato contro il loro signore.
Ad alcuni viene inflitta quella che si intuisce essere una condanna a morte, altri si tolgono la vita; infine, sorprendentemente, quattro funzionari dello stesso tribunale, accusati di aver gozzovigliato con le donne dell’harem, sono condannati al taglio del naso e delle orecchie. Nonostante il riserbo del documento, si intuisce fra le righe che lo scopo della congiura era l’assassinio del sovrano, presumibilmente per mettere sul trono Pentauere, figlio della regina Teye, uno dei suicidi.
La congiura ha davvero portato all’assassinio del faraone? Sembrerebbe di sì. Infatti, nel papiro si dice che il faraone “è fra i re giusti, al cospetto di Ammone e Osiride”: tuttavia la sua morte non viene dichiarata esplicitamente, viene anzi taciuta nel papiro per esorcizzarne l’enormità. Il fatto che Ramesse III fu ucciso da un profondo taglio alla gola, come ha rivelato un recente studio della sua mummia, potrebbe costituire una sinistra conferma di questa teoria.
Il “Papiro della Congiura” è una drammatica testimonianza di come la partita del potere si giochi anche con la manipolazione cruenta della successione al trono, di solito nel segreto del luogo più recondito del palazzo, l’harem del sovrano. Da questo punto di vista la corte dei faraoni egiziani non doveva essere molto diversa da quella dei sovrani greci d’Egitto, i Tolemei, dove gli omicidi fra consanguinei non si contano, o degli imperatori romani, di cui meno della metà è morta nel proprio letto.
Se nel caso dell’antico Egitto questi eventi sono testimoniati da notizie scarne e sparute, è perché nell’Egitto faraonico la parola ha il potere di evocare “magicamente” l’atto. L’attentato alla vita del sovrano è dunque qualcosa di indicibile. L’unico documento egiziano che evoca con realismo la vulnerabilità del re è un testo più antico, l’Insegnamento di Amenemhat I, dove il sovrano defunto racconta al figlio l’assalto notturno che gli costò la vita: “Non accostarti ai tuoi sottoposti quando sei solo, non fidarti di tuo fratello… nessuno è coraggioso la notte, nessuno può combattere da solo”.
Dott. Federico Poole, Curatore del Museo Egizio di Torino




