PHOTO
Lo storico Alessandro Barbero sul palcoscenico del Teatro San Carlo di Napoli
Il 2026 sarà l’anno dedicato all’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi. Un santo tra i più amati, ma forse non sempre conosciuto in profondità. Per farlo, abbiamo chiesto di parlarcene ad Alessandro Barbero, il più noto dei medievalisti italiani, autore di un recente volume intitolato San Francesco (edito da Laterza). Già professore ordinario di Storia medievale all’Università del Piemonte Orientale, Barbero ha scelto di raccontare Francesco con il metodo tipico dello storico: andando, cioè, a ripercorrere le fonti (biografie, cronache, documenti) che per prime hanno parlato di lui.
Professor Barbero, nel suo libro l’immagine del poverello si rifrange nelle diverse voci che l’hanno raccontato. Ma se, al termine delle ricerche che ha condotto, dovesse dire in somma sintesi chi è stato san Francesco, che cosa risponderebbe?
«Un uomo di straordinaria forza di volontà ed enorme carisma, che ha messo un’energia sovrumana e una capacità organizzativa fuori dal comune al servizio di una fede incrollabile e di una visione di grandissima ampiezza. Un uomo che ha impressionato profondamente tutti quelli che lo hanno conosciuto e ha lasciato un’impronta così forte da diventare un personaggio dell’immaginario collettivo, fino a oggi. Ma, al tempo stesso, un uomo tormentato, che ha vissuto in modo conflittuale l’enorme crescita del suo movimento ed è morto chiedendosi se non avesse sbagliato tutto».
Come descriverebbe il suo carattere?
«Francesco è, in realtà, simile ad altri santi fondatori di grandi movimenti, perché è al tempo stesso un mistico, con un rapporto personale con Dio, un trascinatore di folle e un grande organizzatore. Ma non è l’uomo delle certezze, è invece l’uomo che cerca continuamente – nel dialogo con Dio – la conferma che sta seguendo la strada giusta e che è continuamente dibattuto fra il bisogno di stare con gli altri e guidarli, e il bisogno altrettanto forte di isolarsi alla ricerca del contatto mistico col divino».
Quali immagini stereotipate di Francesco le sembra sia giunto il momento di abbandonare?
«In primo luogo, l’idea del santo della letizia, serafico e sempre lieto: al contrario, Francesco è stato, come si diceva, un uomo tormentato e anche soggetto a scatti d’ira. Poi dobbiamo non dico abbandonare, ma contestualizzare quegli aspetti che ci sembrano anticipare la sensibilità odierna: non che non ci siano degli agganci per vedere in Francesco qualcosa che ricorda il pacifismo, l’animalismo, il dialogo interconfessionale, ma dobbiamo sapere che per lui queste spinte avevano radici diverse dalle nostre. Francesco amava gli animali e la natura, ma perché ci vedeva l’impronta del Dio creatore e in polemica con i catari per i quali tutto il mondo materiale era figlio di un Dio malvagio. È andato a parlare col sultano ed è stato un gesto straordinario, del resto ricambiato dalla cortesissima accoglienza ricevuta, ma non ci è andato per dialogare, è andato per spiegargli che i musulmani hanno torto e i cristiani hanno ragione!».
In che modo la Chiesa si è rapportata alla figura di Francesco dopo la sua morte?
«Io non parlerei della Chiesa come una potenza monolitica, contrapposta in qualche modo a Francesco. La Chiesa era allora, anche più di oggi, una realtà complessa e conflittuale. Francesco era dentro la Chiesa come erano dentro la Chiesa quei francescani che dopo la sua morte hanno fatto dell’Ordine una potenza e sono diventati dignitari, vescovi o dottori, e quegli altri francescani che vedevano con sgomento questa evoluzione e sostenevano che Francesco non aveva voluto questo. È la dirigenza dell’Ordine, certo non ostacolata da Roma, che ha gestito e in certa misura travisato il ricordo di Francesco, per attenuare il contrasto fra i suoi insegnamenti (assoluta povertà, lavoro manuale, diffidenza verso i libri e lo studio) e quello che l’Ordine era diventato».


Quali valori “francescani” le sembra che siano presenti nella Chiesa di oggi?
«Non è facile dirlo, perché bisogna che sia ben chiara una cosa. Francesco non ha mai preteso che tutta la Chiesa si adeguasse al suo esempio e praticasse la povertà francescana, non ha mai criticato le autorità della Chiesa né, se è per questo, i laici ricchi e i potenti. Ha sempre detto molto chiaramente che lui all’autorità della Chiesa voleva obbedire e non era un ribelle in senso sociale: l’ideale evangelico di assoluta povertà, umiltà e sottomissione a tutti, lui sentiva di essere stato chiamato a imitarlo e pensava anche che chi voleva essere un frate francescano avrebbe dovuto sforzarsi di fare la stessa cosa, ma non andava oltre e non si sarebbe mai sognato di dire al Papa che cosa avrebbe dovuto fare».
Ci avviciniamo al Natale. La realizzazione del Presepe di Greccio, reso celebre dall’affresco di Giotto, è un fatto storicamente accertato? Che cosa ne sappiamo di preciso?
«La storia del Presepe di Greccio è raccontata nella prima biografia di Francesco, scritta da Tommaso da Celano quando è ancora freschissimo il ricordo di Francesco ed è, quindi, molto probabile che l’episodio così come lo racconta sia autentico. Francesco era a Greccio e, all’avvicinarsi del Natale, decise di ricordare la nascita del Bambino ricreando una vera mangiatoia piena di fieno, con un bue e un asino. E la notte di Natale la Messa venne celebrata davanti a quella mangiatoia, non da Francesco, che non era sacerdote. Era diacono e con i paramenti da diacono prima cantò il Vangelo e poi predicò, ricordando la nascita del Bambino di Betlemme. Tommaso aggiunge che belava come una pecora, prolungando affettuosamente quel nome e si leccava le labbra per il gran gusto quando pronunciava il nome di Gesù».
IN COLLABORAZIONE CON CREDERE
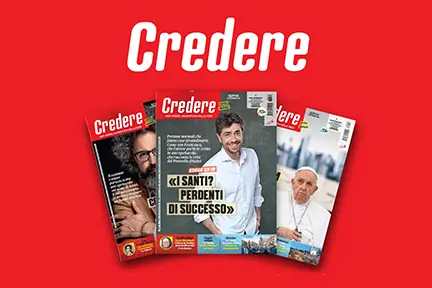
Credere, la rivista per vivere «l'avventura della fede»
CREDERE è la rivista che ogni settimana ti propone storie, personaggi e rubriche per ispirare la fede nel quotidiano. Già scelta come "Rivista Ufficiale del Giubileo della Misericordia", è un giornale ricco di contenuti per lo spirito, con tante testimonianze di famosi e gente comune e i gesti e le parole di Papa Francesco, più vicini che mai.
Scopri la rivista e abbonati »



