PHOTO
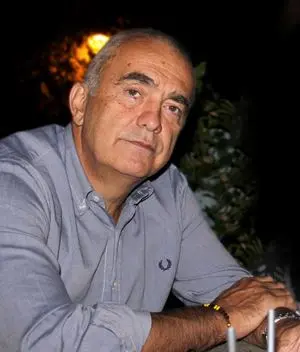
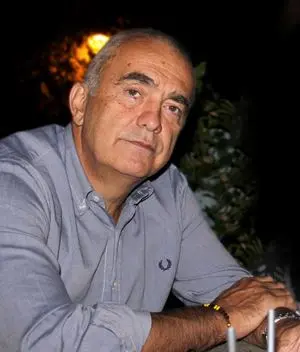
«Sono rimasto affascinato da Franco Basaglia quando ancora andavo a scuola. Un giorno è venuto in classe invitato da un mio professore, che era volontario presso la sua struttura, e ne sono rimasto affascinato, fino a seguirlo per tutta la mia vita». Incontriamo Roberto Colapietro nel contesto delle Settimane sociali di Trieste, al banchetto organizzato dalla Caritas di Trieste e da diverse organizzazioni laicali. Un esempio virtuoso di collaborazione di persone di buona volontà in cui quello che conta non è l’appartenenza ma il cuore.
Operatore socio-sanitario in pensione, Colapietro ha lavorato per una vita nel Dipartimento di Salute mentale di Trieste, la città dell’ex Ospedale Psichiatrico San Giovanni, il laboratorio di idee in cui Franco Basaglia nel 1978 maturò le linee portanti della famosa legge che da lui prese il nome. Famosa perché fu quella che abolì i manicomi e, soprattutto, riconobbe nei malati mentali delle persone da trattare con umanità, cercando di sottrarle alla segregazione a cui erano condannati per tutta la vita per cercare di reintegrarle nella società. Con quella legge i “matti” avevano finito di essere rinchiusi in strutture appartate e di vivere vite di sofferenza inaudita.
Per la cronaca l’ex Ospedale psichiatrico è diventato il Parco Culturale di San Giovanni, un giardino aperto e un laboratorio di imprenditoria sociale, di attività assistenziali e creative in cui si vivono a favore della città proposte culturali e di formazione. Non solo le persone, dunque, ma anche i luoghi della segregazione con quella riforma vissero la loro risurrezione.
Colapietro, cosa resta della riforma a cent’anni dalla riforma Basaglia?
«La nostra società sta cambiando, e non sempre in meglio. La povertà aumenta a dismisura e nell’ambito della sanità sono state create delle managerialità fredde che prestano più attenzione al budget che alla vita concreta delle persone. Proprio il contrario di quello a cui aspirava Franco Basaglia».
In che senso?
«Lui ha sempre messo al centro la persona, perché ha un valore, perché va rispettata soprattutto quando è fragile, come nel caso della malattia mentale. Basaglia non ha mai negato che esista la sofferenza e la follia, ma è sempre stato molto critico verso la psichiatria classica, che in quell’epoca aveva una funzione di controllo sociale, che non affrontava la sofferenza umana ma esercitava di fatto un potere nei confronti di chi stava male. I manicomi erano un modo per mettersi socialmente la coscienza a posto. In quella epoca non si poteva dire: “Chi sta male lo chiudiamo in un lager”. Ma quella era la triste realtà».
E oggi a che punto siamo?
«A distanza di 100 anni dalla sua nascita, con il contesto che ci sta intorno, dobbiamo riconoscere che è tutto più difficile. È vero, a Trieste quando ci visitano da tutto il mondo restano ancora affascinati dai percorsi di salute mentale che offriamo, ma abbiamo lacune enormi. Solo un esempio: se è fondamentale avere un servizio di cura mentale nel territorio, lo è altrettanto averlo aperto 24 ore su 24 e tutti i giorni della settimana, perché la sofferenza mentale di chi è malato e dei suoi familiari non ha la settimana corta. Banalmente un centro di salute mentale ormai sono anni da noi non può fare più le notti perché mancano infermieri».
Come mai?
«L’Organizzazione Mondiale della Sanità ci guarda ancora come punto di riferimento, ma i nostri “supermanager” non riescono a trovare infermieri per fare la notte. Un giorno un genitore mi diceva: “Roberto, mio figlio non sta bene. Prova a pensare, sta nel centro diurno per l’ospitalità e poi per la notte lo portano in un altro centro di salute mentale e la mattina dopo lo riportano di nuovo là. Ma ti sembra giusto?”».
E nel resto del Paese com’è la situazione?
«Basta andare in giro per l’Italia e ci si accorge che oggi è più importante la diagnosi della cura. Molte persone vivono ancora legate al letto con una diagnosi perfetta nella loro cartella clinica... Basaglia, in una delle sue ultime conferenze in Brasile, disse che un giorno i manicomi potrebbero tornare peggiori di prima. E purtroppo in molti posti questo è diventato realtà».
Può spiegarci meglio?
«Molta gente sulla soglia della marginalità sociale e con problemi mentali vive in carcere. Commette un piccolo reato e resta in cella per mesi e anni imbottita di farmaci. In Italia ci sono 5 mila persone. E altre 30 mila vivono in appartamento sotto rigido controllo medico e sociale perché non creino problemi per strada. Ma in cambio quanta gente c’è oggi per strada malata di mente? Purtroppo anche qui l’America ha fatto scuola. Pensi che solo a Los Angeles ci sono 60 mila persone senza fissa dimora, molte delle quali con disturbi psichici. Evidentemente la logica manageriale del contenimento dei costi senza umanità non funziona».
Vede qualche speranza?
«Vedo con gioia che ci sono nuove generazioni che sono attente alle sofferenze dei malati di mente, che non si fanno influenzare o appiattire dai falsi miti dell’individualismo e del carrierismo. Però è anche vero, purtroppo, che sempre di più in Italia c’è povertà, giovani che lasciano il paese, ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri».
Serve uno scatto…
«Il problema è articolato. Non esistono investimenti sufficienti per garantire la salute sul territorio, ma c’è anche – ripeto – una visione della salute mentale che vede centrale la diagnosi. Va bene la diagnosi, ma dopo? Spesso e volentieri la diagnosi mi sembra solo funzionale alla riproduzione di un sapere psichiatrico, anzi di un potere sulla persona. “Io so, io ti ho classificato in una certa maniera…”. È superficiale immaginare che una volta che hai fatto la diagnostica hai risolto il problema».
Cosa occorre fare, allora?
«Ho lavorato un lungo periodo con una cooperativa sociale, la Cooperativa Lavoratori Uniti, che è la prima nata in Italia nel 1972 che ha lavorato per offrire delle opportunità alle persone malate di mente. Dar loro un ruolo, un reddito, un contesto di lavoro e delle relazioni umane. Da qui si riparte per una umanizzazione. Non significa che in automatico si guarisce, significa però che una persona può costruire un percorso di salute mentale in cui si integrano le cure e una vita degna».
Come coniugare questa situazione col titolo delle Settimane sociali, cioè “democrazia e partecipazione”?
«Democrazia significa il potere alla gente. La sanità è qualcosa che finanziamo con i nostri contributi, miei e quelli di milioni di italiani. Mi sembra sempre più spesso che la cura sia invece considerata una concessione. Penso che dobbiamo ribellarci all’apologia astratta del “non ci sono soldi”. Dobbiamo riappropriarci dei nostri diritti, perché lo Stato siamo noi. Non possiamo più credere alla logica del manager, che deve risparmiare, far quadrare i conti, emettere diagnosi che sembrano risolvere il problema ma in realtà non lo fanno. Dobbiamo riappropriarci, in quanto cittadini, di del bene comune. Percorso complicato, sì, ma quella è la strada».





