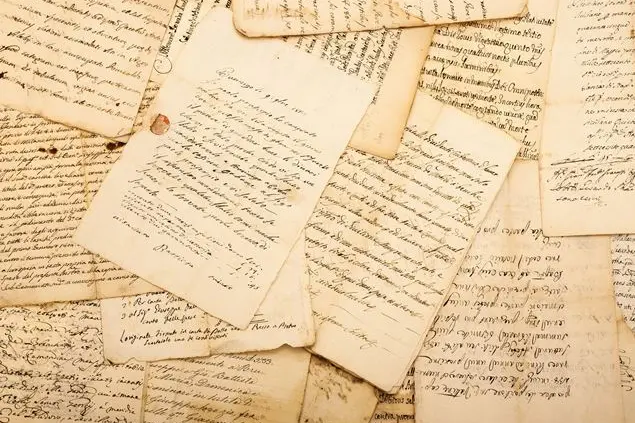PHOTO


Verba volant, scripta manent. A patto, aggiungiamo, che questi scritti vengano tutelati, non solo dall'inesorabile scorrere del tempo, ma anche da disastri ambientali che potrebbero danneggiarli. Massimo Cruciotti, fondatore della società Mazzini Lab Benefit e della onlus SOS Archivi, si occupa di protezione, gestione e valorizzazione di archivi, biblioteche e beni culturali: ci parla dell'importanza di custodire il patrimonio artistico-culturale, a partire da una corretta valutazione dei rischi.
Cruciotti, partiamo dal tema della conservazione: in un mondo così concentrato sull’immediatezza del "qui e ora", perché è necessario preservare il passato?
«Perché la nostra storia lascia traccia del nostro passaggio, anche se non ne siamo consapevoli. È compito di una collettività organizzata occuparsi della conservazione dei beni storici, per costruire memoria e identità: se tutti ci impegniamo nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio culturale, lo rendiamo accessibile alle generazioni future. Questa è la responsabilità che io sento a livello personale e che cerco di trasferire nelle mie attività profit e non profit».
Che difficoltà si incontrano, svolgendo un lavoro di tutela del patrimonio artistico?
«Il cambiamento climatico sta avendo un impatto importante, perché negli ultimi dieci anni gli eventi estremi si sono intensificati, diventando sempre più frequenti. L’Italia è un Paese fragilissimo, dove più del 60% del territorio è a rischio idrogeologico. Durante l’alluvione in Emilia Romagna, ad esempio, moltissimi archivi e biblioteche sono stati messi a dura prova: grazie all’intervento dei volontari, in coordinamento con i ministeri e le istituzioni, è stato fatto un importante lavoro di recupero, ma nei prossimi anni questi beni dovranno essere asciugati e restaurati».
La sua fondazione SOS Archivi è nata proprio nel 2009, a seguito del terremoto a L’Aquila. Quali sono i primi passi da fare, in caso di catastrofi naturali, per mettere in sicurezza il patrimonio artistico?
«Quando abbiamo fondato l’associazione abbiamo partecipato alla stesura delle linee guida, pubblicate poi dalla Direzione generale Archivi del Ministero della cultura e a cui tutti fanno riferimento. Al verificarsi di un’emergenza ambientale si organizzano dei campi sul posto, con un’area triage dove i beni vengono movimentati con cautela, e successivamente viene effettuata una prima valutazione del danno: a seconda delle condizioni dei materiali, si seguono procedure specifiche».
Parliamo di un Paese, l’Italia, che è intriso di opere d’arte. Com’è la situazione generale di conservazione dei beni?
«Abbiamo un patrimonio importante da difendere, ma proprio per la sua vastità circa il 90% di questo patrimonio è conservato in depositi. C’è un’attività da svolgere sia all’interno delle sale espositive, sia dal punto di vista della conservazione e del monitoraggio delle condizioni microclimatiche, che deve essere fatta con nuove tecnologie e nuovi metodi in grado di consentire un controllo puntuale. Noi in questo senso siamo impegnati in attività di formazione e spesso organizziamo workshop di approfondimento, per diffondere la cultura della prevenzione del rischio e della corretta conservazione di beni culturali».
A proposito di rischi: a ottobre partirà il corso di formazione in Risk management per l’arte. Di cosa si tratta?
«È un’iniziativa “pionieristica”, nata da una collaborazione tra Mazzini Lab Benefit, LCA Studio legale e Cepas Bureau Veritas. A renderla unica è il fatto che si tratta di un percorso professionalizzante certificato: gli studenti superano un percorso interdisciplinare (che li porta ad avere una formazione da esperti nella protezione del patrimonio culturale dai rischi) e ricevono un attestato; dopodiché vengono iscritti in un albo pubblico. L'idea di fondo è che se un rischio viene ben valutato e dichiarato si possono attivare una serie di attività di riduzione dei rischi o di intervento».
Secondo lei, qual è l’impatto della cultura sulla società?
«Dall'ultimo rapporto di Symbola e Unioncamere emerge che la cultura è un formidabile attiratore di economia: nel 2022 questo il settore ha generato un valore aggiunto pari a 95 miliardi di euro, mentre alcune imprese che lavorano nella filiera sono arrivate a occupare quasi un milione e mezzo di persone. Questi dati colpiscono, perché danno un’idea concreta di quanto la cultura sia sia importante anche a livello economico. Dobbiamo impegnarci affinché tutto il nostro patrimonio venga tramandato alle generazioni future».