PHOTO
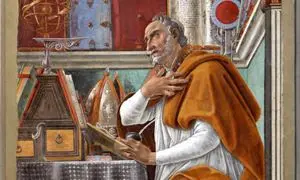
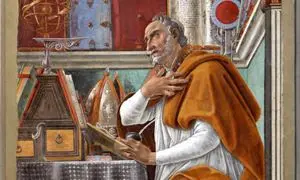
Su suggerimento di una coppia di parrocchiani, ho assistito allo spettacolo/monologo di Giovanni Scifoni, che in questi giorni si rappresenta al Teatro sala Umberto di Roma, dal titolo “Santo piacere 2.0 – Dio è contento quando godo”. Il brillante attore è anche autore di un piccolo libro edito da Mondadori: “Senza offendere nessuno. Chi non si schiera è perduto”, nel quale propone la sua filosofia di vita in costante e pressante confronto con la Chiesa cattolica. Con queste riflessioni mi inserisco fra quanti in campo cattolico apprezzano e hanno applaudito a queste imprese, anche su questo sito, che riprende una bella intervista su Credere.
La pièce teatrale è un inno all’“amore per sempre” e si dipana nel continuo, quasi assillante, tentativo di smascherare i luoghi comuni che riguardano il rapporto Chiesa / sesso, attraverso una serie di aneddoti, tratti dalla vulgata condivisa, che vanno da Origene ad Agostino, da Santa Caterina e San Francesco all’enciclica “Humanae vitae” di Paolo VI. Il messaggio che emana da questa tragicommedia risulta estremamente positivo e controcorrente nello stesso tempo. Già il sottotitolo mi riportava ai famosi tre verbi pronunziati da Antonio Rosmini sul letto di morte, con Alessandro Manzoni al suo capezzale, che gli chiedeva: «Cosa faremo noi senza di Lei?». Il Roveretano rispondeva «Adorare, tacere, godere». Scifoni intende, e devo dire che ci riesce, contrastare l’idea che il Cristianesimo e la Chiesa siano per presa di posizione preconcetta contro il piacere e l’esercizio della sessualità. Il don Mauro cui costantemente si riferisce, per quanto a tratti reticente, non colpevolizza mai il suo interlocutore, ma lo invita sempre e comunque a fare i conti con la complessità di certi quesiti morali.


Se è vero – come afferma il Talmud – che «Dio ha creato l’uomo con l’impulso delle sue passioni, ma ha dato la Sua Parola come antidoto», non va tralasciato il suggerimento dell’autore, secondo il quale il termine ebraico utilizzato nel testo תבלין (= tablin) non significa solo “antidoto”, ma anche, se non soprattutto, “spezia”, ovvero condimento che rende saporito il cibo.
Lo stesso racconto della presunta auto-evirazione di Origene, con la conseguente perdita di ispirazione creativa, l’esclusione dal presbiterato e il mancato accesso alla canonizzazione sta a significare che né Dio né la Chiesa vogliono la nostra castrazione, né fisica e tanto meno mentale. Il senso di questo racconto, che la critica aiuta a demitizzare, sta proprio in questo messaggio col paradosso che chi, come l’Alessandrino, avrebbe dovuto assumere una interpretazione allegorica del famoso brano evangelico, in coerenza con la propria teologia, lo intende purtroppo in senso letterale, assumendo un inaccettabile fondamentalismo: «Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue» (Mc 9, 43-48).
Certamente suggestivo il richiamo ad un altro apologo, spesso riportato in chiave aneddotica (lettera apocrifa a Cirillo), di Agostino, che si sente dire da un fanciullo che come non si può rinchiudere l’acqua del mare in una fossa, così è impossibile comprendere il mistero di Dio in una piccola mente, come quella di ciascuno di noi, anche di un genio come l’Ipponate. Altrettanto significativo il richiamo alla storia della lampadina, che nell’intenzione originaria del suo inventore, avrebbe dovuto durare per sempre, ma viene, per motivi commerciali soppiantata da un oggetto che deve perire perché se ne possano vendere altri esemplari. Sicché, è lecito dedurne, che l’amore fu creato per durare per sempre, ma inquinato da ideologie consumistiche e materialiste ha finito per essere considerato transeunte.


Quanto alla Humanae vitae, l’autore/attore ne ricostruisce la vicenda, interpretandola come una vittoria del tradizionalismo che vieta ogni artificiale contraccezione, richiamando, insieme al carattere unitivo, quello procreativo della sessualità. Ma è sorprendente come Scifoni aggiunga che sua madre avrebbe letto l’enciclica, o almeno ne avrebbe sentito parlare, decidendo così di dare alla luce il suo quarto figlio, ossia lui stesso. Sarebbe come dire che senza quel magistero lui non sarebbe mai nato. E la domanda che percorre tutta l’impresa si formula nel modo seguente: se fosse così facile da parte della Chiesa o del Papa annunciare che ognuno può fare ciò che vuole in materia sessuale, perché non farlo, visto che la morale cattolica in questo ambito allontana le persone distogliendole anche dall’assegnare l’8x1000 alla Chiesa? Se fosse vero che quest’ultima persegue solo interessi materiali, da tempo avrebbe modificato il proprio codice antropologico rispetto al matrimonio, alla famiglia, alla sessualità.
Ciò che commuove profondamente lo spettatore sono le batture finali della rappresentazione. Qui l’autore riferisce l’esperienza di due coniugi (i suoi genitori), che, nel momento in cui si sono incontrati, avevano nell’immediato un solo scopo: portare a letto l’altro. E continuano a portarsi a letto anche nel momento in cui, il papà ormai anziano prende in braccio ogni sera la moglie paralizzata e in sedia a rotelle e l’adagia nell’alcova, perché l’amore, se autentico, anche carnale è “per sempre”. Le pagine del IX capitolo libro di Scifoni, intitolato “Più grandi di Dio” contengono riflessioni sulla “testimonianza” e sul “miracolo” che non hanno nulla da invidiare alle nostre teologie (spesso atee). Sono uscito dalla sala (gremita di una folla plaudente e a tratti ridanciana) riflettendo sul fatto che possono incidere sul cuore e sulla mente delle persone molto di più uno spettacolo e un libro come questi di tante nostre prediche, trattati o elucubrazioni teologiche.
(Nella foto di copertina, Giovanni Scifoni)





