PHOTO
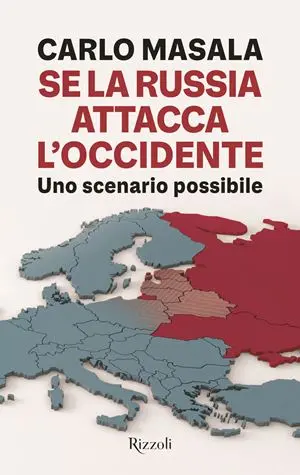
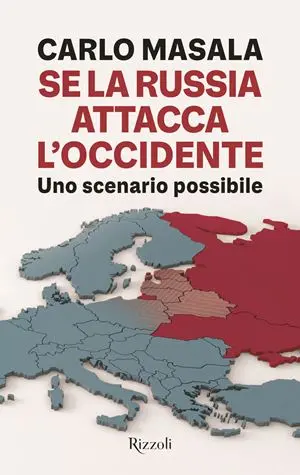
È il 27 marzo 2028. Nelle prime ore del mattino l’Estonia si ritrova con i soldati russi in casa, nella città di Narva e, poi, nell’isola di Hiumaa, nel Mar Baltico. La guerra in Ucraina è finita da tre anni, con pesanti perdite territoriali e strategiche imposte a Kyiv e, di fatto, la vittoria di Mosca. Ora, l’Europa si risveglia con una nuova azione russa all’interno dei suoi confini. Un’aperta provocazione. Un modo per mettere alla prova la capacità e la volontà di difesa dell’Europa e della Nato. Come deciderà di reagire l’Alleanza all'azione del Cremlino, che nel frattempo ha scelto un nuovo leader al posto di Putin?
In Se la Russia attacca l’Occidente. Uno scenario possibile (Rizzoli) l’autore Carlo Masala, noto politologo, ricercatore e analista tedesco, docente di Politica internazionale presso l’Università delle Forze armate tedesche di Monaco, disegna una prospettiva geopolitica futura con l’andamento e lo stile vivace e coinvolgente della fiction. Eppure, non siamo affatto nel campo della pura immaginazione, lontani dalla realtà, e da ciò che effettivamente potrebbe accadere. Siamo in uno scenario, per l’appunto, possibile. Il futuro è aperto. La guerra in Ucraina potrebbe effettivamente finire con la vittoria della Russia. “E se questo fosse solo l’inizio?”, è la domanda di Masala nella prefazione. “E se, in realtà, ci fossero in palio la sicurezza europea e l’intero ordine mondiale liberale e noi stessimo ancora una volta chiudendo gli occhi”?. Mentre la Russia continua a sferrare attacchi massicci sul territorio ucraino, naufraga l’idea di un incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin a Budapest) e il presidente Usa invoca nuove sanzioni contro Mosca, il professor Masala analizza con Famiglia Cristiana la situazione del conflitto e i suoi possibili sviluppi.
Professor Masala, alcune settimane fa il passaggio di droni nei cieli di vari Paesi nordeuropei a partire dalla Polonia e lo sconfinamento di jet russi hanno reso lo scenario del suo libro molto concreto. E non nel 2028, come immagina lei, ma già oggi, nel 2025. È così?
Ciò che è successo in Polonia, in Estonia di fatto non è qualcosa di nuovo, ma ci mostra la temerarietà dei russi. Se pensiamo al passaggio dei droni in Polonia, ai jet russi sconfinati nei cieli dell’Estonia, capiamo che la volontà di assumere dei rischi da parte dei russi è evidente. Mi domando: perché i russi stanno osando così tanto? E la risposta è: perché non credono più nella forza della deterrenza. Non credono più nella possibilità che la Nato reagirà unita contro questo tipo di provocazioni. Dunque, non siamo ancora dentro lo scenario da me descritto nel libro, ma ci stiamo muovendo rapidamente verso quella direzione.
Possiamo dire che più la Nato e l’Europa diventano forti e uniti a livello di difesa, più diventa difficile per la Russia acquistare potere e farlo valere?
Certamente, le due cose sono correlate. E c’è un terzo aspetto da considerare: quanto è probabile che gli europei nel futuro usino davvero le armi – navi da guerra, carri armati, jet - che acquistano? Questo è proprio il lato debole della deterrenza europea: essere capaci di far capire in modo chiaro alla Russia che, in caso di attacco, gli europei userebbero davvero quelle armi.
Nel suo libro lei dice in modo molto chiaro: l’Europa sottovaluta la minaccia che la Russia rappresenta non solo per l’Ucraina ma per tutti noi. E non ci rendiamo conto che questa non è una guerra fra due Paesi, ma in gioco c’è l’ordine liberale internazionale.
La mia idea è che quanto più ci si allontana geograficamente dalla Russia tanto più i Governi e le società non credono in questo scenario. Abbiamo la precisa evidenza che i droni arrivati nei cieli della Polonia fossero russi. Eppure tanti in Europa hanno pensato che non arrivassero da Mosca e che non si trattasse di una provocazione russa. E’ davvero sorprendente come la disinformazione russa agisca nei Paesi europei e abbia agito negli ultimi dieci anni. In Paesi come la Germania e l’Italia una larga parte del dibattito pubblico ritiene che l’invasione russa sia stata colpa dell’Ucraina e che la Russia non può essere sconfitta perché è una superpotenza.
L’azione della propaganda russa è dunque molto forte e pervasiva oggi in Europa?
È estremamente forte, perché è già attiva da un decennio. Ha presente il controllo riflessivo (ovvero, una tecnica manipolatoria in base alla quale un individuo esercita un controllo sulle azioni del proprio avversario)? È stato inventato dai russi. Nell’esercito sovietico già negli anni ’70 gli psicologi militari affermarono: Abbiamo bisogno di creare un ambiente nel quale i nostri nemici prendono decisioni pensando che quelle decisioni sono nel loro interesse, mentre in realtà sono nel nostro interesse. E questo è il controllo riflessivo. E fin dagli anni ’70 i russi lavorano intensamente su questo meccanismo e vediamo oggi come funziona bene. La propaganda russa è stata così efficace che l’Europa nel 2023 ha aspettato cinque o sei mesi prima di prendere la decisione di fornire i carri armati a Kyiv, perché i russi minacciavano di usare la forza. Ma in questi cinque o sei mesi, i russi hanno potuto penetrare in profondità nel sud dell'Ucraina, così che una volta presa la decisione di fornire i carri armati, l'offensiva era destinata a fallire perché il terreno nel sud dell'Ucraina assomigliava al sistema di trincee che avevamo in Europa nella Prima guerra mondiale. L’altro elemento da considerare: più che mentire in modo palese, i russi sollevano dei dubbi. Prendiamo il caso dei droni: la propaganda russa ha fatto nascere la domanda, ma abbiamo foto di questi droni? Siamo sicuri che siano russi e non ucraini? Ecco il punto: non si tratta di diffondere menzogne, ma di instillare dubbi nelle società, in coloro che non sono filo-russi. Creando questi dubbi, si crea un contesto nel quale le persone pensano di non sapere più a chi e a cosa credere. Instillare dubbi è molto più potente ed efficace che mentire in modo palese. Ed è per questo che la propaganda russa funziona così bene. Io lo vedo in Germania: sempre più persone non sanno più a chi dare credito, al Governo o ad altre fonti?
Il ministro degli Esteri russo Lavrov continua a ripetere che bisogna rimuovere le cause profonde alla base del conflitto, ma senza mai dichiarare apertamente a cosa si riferisce. Quali sarebbero le cause profonde? In definitiva, perché la Russia ha attaccato l’Ucraina e quali sono i suoi obiettivi ultimi?
Per capire quali sono queste cause profonde bisogna tornare alla lettera che Lavrov ha scritto all’allora segretario di Stato Usa Blinken il 17 dicembre 2021. Una lettera simile è stata inviata anche al quartier generale della Nato. Per la Russia, la causa principale di questa guerra è lo sviluppo del sistema di sicurezza europeo dal 1997. I russi sostanzialmente vogliono tornare all'ordine di sicurezza europeo del 1997, il che significa nessuna presenza di forze americane in Polonia, Romania, nei Paesi Baltici e, secondo alcuni, nemmeno in Kosovo. In secondo luogo, questo per la Russia è il presupposto per dominare politicamente ed economicamente alcuni dei Paesi vicini al confine, gli Stati baltici, la Romania, la Bulgaria e così via. Per Mosca la Nato dovrebbe ritirarsi dall'Europa orientale. E questo è stato espresso nella lettera inviata da Lavrov agli Stati Uniti e a Bruxelles nel 2021. Per quanto riguarda l'Ucraina, ovviamente Mosca non dirà mai cosa vuole realmente ottenere perché, alla fine dei conti, deve ottenere un risultato che rappresenti una vittoria. Ma è molto chiaro che i russi vogliono mantenere ciò che hanno preso: il controllo delle zone occupate, più il 20% del Donbas che non possiedono. Allo stesso tempo non vogliono garantire alcuna sicurezza all'Ucraina. Vogliono rimuovere Zelensky dal potere e continuano a dire che non firmeranno alcun trattato con lui. Inoltre, i russi vogliono che l’Ucraina abbia un esercito piccolo e sostanzialmente indifeso. Alla fine dei conti, mirano a esercitare facilmente un’influenza sul resto dell’Ucraina, in quanto priva di un esercito forte e di garanzie di sicurezza. E probabilmente nelle prossime elezioni in Ucraina punteranno a interferire facendo presentare qualche candidato più amico della Russia.
L’incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin che avrebbe dovuto tenersi a Budapest è naufragato e il presidente Usa ha di nuovo affermato che l’omologo russo non vuole la pace. Lei nel suo libro afferma chiaramente che Putin è un dittatore. Possiamo davvero credere che il leader del Cremlino sia disposto a “piegarsi” e accettare un negoziato di pace deciso e disegnato da un altro grande leader di una superpotenza?
Putin si è innervosito quando gli Stati Uniti hanno iniziato a parlare della fornitura di missili Tomahawk a Kyiv. Poi, ovviamente, c'è stato l'incontro fra Trump e Zelensky a Washington, e tutti pensavano che il risultato potesse essere che Trump avrebbe accettato di inviare un certo numero di missili Tomahawk all'Ucraina. Il giorno prima, Putin era pronto a parlare con Trump. Perché? Ovviamente perché voleva evitare la consegna dei missili. E poi ha fatto quello che fa sempre con Trump: lo ha adulato. Ha proposto una sorta di progetto economico, il tunnel tra la Russia e gli Stati Uniti che dovrebbe essere costruito da Elon Musk. E queste sono le cose che piacciono a Trump: grandi progetti, investimenti, soldi in arrivo e così via. E il presidente Usa ha immediatamente cambiato idea. Si parlava dell’incontro a Budapest. Se fosse avvenuto, per Putin ovviamente sarebbe stata una grande vittoria. Ma i russi sono dei diplomatici molto scaltri. Nelle negoziazioni sono abili a rimandare, a prendere tempo, questa è la loro strategia. Così, nel frattempo, possono continuare a fare la guerra.
Nella risoluzione della guerra in Ucraina, Donald Trump è più un aiuto o un ostacolo?
È un ostacolo, perché non ha alcun interesse nella guerra in Ucraina. Il suo unico interesse è normalizzare le relazioni con la Russia, soprattutto in campo economico, fare affari con Mosca e Kyiv, non gli interessa altro. Non gli importa davvero nulla dell'Ucraina. Non ha alcun interesse a danneggiare Mosca. Tuttavia, solo procurando un danno economico alla Russia è possibile portarla al tavolo delle trattative e renderla disposta al compromesso.
E’ possibile porre fine alla guerra sul campo di battaglia, con le armi?
No. Questa guerra avrebbe potuto essere vinta sul campo di battaglia due anni fa, se l'Europa e gli Stati Uniti avessero chiarito fin da subito che avrebbero inviato all'Ucraina tutto ciò di cui aveva bisogno. C'era una possibilità. Ora è finita. È più probabile che questa guerra vada avanti per altri tre o quattro anni fino a quando qualcuno non sarà esausto, che siano i russi o gli ucraini.
L’Unione europea (con Ungheria e Slovacchia contrarie) ha dato il via libera allo stop all’importazione di gas russo. Washington ha annunciato sanzioni alla Russia. Pensa che le sanzioni economiche possano essere la strada per portare davvero Putin a trattare?
Le sanzioni, per essere efficaci, devono avere una lunga durata nel tempo. In secondo luogo, la Russia, in quanto Paese autoritario, ha sempre la possibilità di eludere le sanzioni, di aggirarle. Ed è qui che emerge il punto debole. Gli europei non sono mai stati disposti a colmare le lacune delle sanzioni. Faccio un esempio, che vale anche per l'Italia. Recentemente è stato pubblicato un articolo su The Economist che mostrava come si sono sviluppate le esportazioni di vari Paesi europei, Italia e Germania, verso il Kazakhstan. In alcuni casi hanno registrato un aumento del 400%. Perché? Ovviamente quelle merci dal Kazakhstan vengono esportate in Russia. E noi non abbiamo mai imposto sanzioni secondarie. Non siamo disposti a farlo. Un altro esempio riguarda i droni Shahed usati dai russi: il 50% delle parti di cui sono composti questi droni provengono da industrie occidentali. Quindi le sanzioni fino ad oggi non hanno funzionato come avrebbero dovuto. Se guardiamo all’invio di armi dall’Europa, da marzo a oggi ha avuto un crollo del 50%. Eppure, l'unico modo per porre fine a questa guerra e consentire all'Ucraina di sopravvivere come Stato sovrano è aumentare i costi per Mosca. Bisogna esercitare una maggiore pressione sulla Russia sul fronte economico e fornire all'Ucraina le armi di cui ha bisogno per aumentare il prezzo della guerra per i russi. Questa strada richiede certamente tempi più lunghi, ma è quella più efficace.
(Nella foto di Anna Weise: Carlo Masala, 57 anni, politologo e analista tedesco, docente di Politica internazionale)




